© Gabriele Vitella
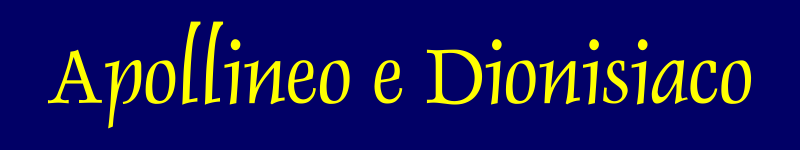
Un blog che vuol essere un caffè con le Muse.
Senza l’Arte non potremmo essere vivi.
| 8 Dicembre 2024 |
||
| Trittico inaugurale | ||
|
Dopo
una lunga pausa, riprendo ad occuparmi
di musica e – nello specifico – di
lirica. Da più parti ed in
più occasioni, amici e semplici conoscenti
mi hanno chiesto di ritornare a recensire
qualcosa, dopo lo spettacolo del San Carlo
di maggio del 2023. Avevo deciso di
non occuparmi più di questo settore per più
ragioni, ma la passione resta tale,
indipendentemente dai propositi e dalla
temperie del momento storico, che – molto
francamente – non è proprio dei migliori. E poi, scrivere di
musica mi rilassa e mi carica assieme. Sono quindi
d’accordo con Friedrich Nietzsche
nell’affermare che «ohne Musik wäre das
Leben ein Irrtum». Senza la musica,
la vita sarebbe un errore. Assolutamente
corretto. E dunque, in
quello che è stato un vero e proprio tour
de force (ma gradevolissimo) come mi
accadeva di fare un tempo, ho scelto tre
inaugurazioni di stagione. Regio di Torino,
Opera di Roma, Scala di Milano. Una trasferta, uno
spettacolo nella mia città, l’esperienza
televisiva che in molti hanno potuto
apprezzare comodamente da casa. Certo, una
poltrona di platea o l’intimo raccoglimento
di un palco sono ben altra cosa rispetto al
salotto di casa propria, ma sono esperienze,
queste ultime, che a livello interiore
arricchiscono in egual modo. Anche se il
rito della sala è qualcosa di
cui il pubblico non dovrebbe poter fare a
meno. Certo, se il
numero delle recite non fosse così esiguo
rispetto alla potenziale domanda, il
discorso sarebbe diverso. Ma allestire uno
spettacolo d’opera richiede mezzi ed un
impegno economico che la nostra società
contemporanea pare non potersi più
permettere come si faceva una volta. Se un teatro
riesce ad allestire al massimo sette
rappresentazioni del medesimo spettacolo
nell’arco di un mese, forse dovremmo
chiederci quanto e come le istituzioni
pubbliche possano sostenere una spesa
decisamente maggiore per quella che è stata
la forma di spettacolo più popolare nel
periodo in cui la nostra nazione si è
formata ed ha cominciato a crescere. Guardiamo al
passato ed osserviamo il presente. Quanti giovani
potremmo indirizzare verso questo tipo di
Arte, che anche oggi lascia dei messaggi di
spaventosa attualità ed interesse? Per un singolo
concerto pop o rock si muovono masse di
ragazzi (e non), che pagano fior di
quattrini anche solo per stare in piedi in
uno stadio. Legittimo, per
carità. La musica cambia, si evolve (o
s’involve?) e quelli che erano miti fino a
pochi anni prima vengono considerati quasi
preistoria dai millennials. E dalle
generazioni precedenti, ovviamente. L’era del
consumismo abbraccia (o per meglio dire,
stritola) anche i generi musicali. Ed anche per
eventi di questo tipo, che riempiono i
succitati stadi, le date sono relativamente
poche. Eccezion fatta per
i musical (la cui qualità non è
sempre eccelsa, va detto e financo ripetuto)
che vanno in tour e che magari pure
loro abbisognano di qualche data in più. Tutto
centellinato. E comunque, fatta
questa breve tirata, direi che posso passare
a questo trittico di inaugurazioni. Cominciamo dalla
prima data, significativa per tanti versi. Torino, 29
novembre 2024. Non ho scelto
l’effettiva inaugurazione della stagione,
partita il 23, per una ragione che potrà
sembrare curiosa. Molto tempo fa,
quando ancora non scrivevo di musica, parlai
con un vecchio critico. Uno bravo, molto
molto bravo quanto anziano. Mi disse che non
bisognerebbe mai, se proprio non se ne può
fare a meno, recarsi ad ascoltare la prima
rappresentazione. Orchestra e
cantanti sono spesso nervosi e (giustamente
eccitati) per il primo impatto che l’opera
ha nei confronti del pubblico. Ed anche se
ci sono i contatti preliminari con la
generale (ed in questi ultimi tempi la
cosiddetta anteprima giovani), la
prima sera, nonostante le cose possano
andare benissimo, il meglio di sé l’ensemble
lo offre nelle rappresentazioni successive.
Meglio se con il primo cast. Consiglio che
seguo tutte le volte che posso. Le recensioni sono
più obiettive e tengono conto di fattori che
sfuggono, ahimè, a molti. Anche a certi
critici che appaiono (e sono, in effetti)
molto preparati e con anni di articoli alle
spalle. Per essere
assolutamente oggettivi, bisognerebbe
recensire dopo la fine dell’ultima
replica. Ma, ovviamente,
non si può. Si deve darne conto molto prima. Questo, con i
tempi di un giornale, cartaceo oppure meno,
o quelli ancor più rapidi di un’emittente
televisiva. Non è questo il
caso. Insomma, 29
novembre. Apertura di
stagione al Regio di Torino con Le nozze
di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart
in un allestimento classicissimo già
presentato al Teatro Real di Madrid per la
regia di Emilio Sagi e con un cast di tutto
rispetto. Biglietto
acquistato con larghissimo anticipo,
addirittura alla metà di luglio,
all’apertura del botteghino telematico per
la nuova stagione. Chi avrebbe mai
potuto anche solo lontanamente immaginare
che CGIL e UIL potessero indire lo sciopero
generale proprio per quella data, mettendo a
rischio qualsiasi tipo di attività, comprese
quelle artistiche? Spettacolo in
forse fino all’ultimo minuto e pubblico
avvertito un paio di giorni prima via mail,
direttamente dal teatro. Parto comunque.
Nella peggiore delle ipotesi, avrei provato
ad assistere a quella che sarebbe stata
l’ultima recita, due giorni dopo, nella
speranza di poter trovare un posto,
ovviamente. In una Torino
blindata, con gli scioperanti in corteo e
scontri tra anarchici e polizia (lo strepito
si sentiva da via Po, ad una certa distanza
da piazza Castello e quindi dal Regio) alla
mattina, mi sono augurato che le cose
potessero andare meglio in serata, come si
suol dire a bocce ferme. Ebbene, si entra
in teatro. Sala praticamente
piena. Io seduto nel mio posto di prima
fila, in trepida attesa. Viene dato
l’annuncio. Una notizia buona, altre due no. Lo spettacolo si
fa. Bene. Benissimo. Niente
attrezzisti, scena (bellissima, peraltro)
fissa. Il cembalista non
suona. Quindi, niente recitativi. Il diritto di
sciopero è sacrosanto, per carità. Ma va apprezzata enormemente
la professionalità di ogni singolo cantante,
carico e pronto dietro le quinte per la
gente in sala. Come pure quella
dei professori d’orchestra, al loro posto. Più di metà del
pubblico abbandona la sala rumoreggiando non
poco. Male. Per rispetto
degli artisti, a mio modestissimo giudizio,
il teatro sarebbe dovuto rimaner pieno. Una pesante nota
di demerito per chi è andato via. Anche perché si è
perso moltissimo. Seppure in questa
forma di semiconcerto mutila dei
recitativi, lo spettacolo è stato
gradevolissimo. Quasi fosse stato per pochi,
intimi amanti della musica. Un plauso a parte
alla coreografia di Nuria Castejon, che fa
danzare il fandango accompagnandolo con le
nacchere. Piacevolissimo e di sicuro
effetto. La direzione di
Leonardo Sini è morbida, leggera, in linea
con la prassi interpretativa. Accompagna
l’orchestra con garbo e pulizia. Applausi
sentiti da parte del pubblico rimasto, che
ha potuto apprezzarne la freschezza. Ed ora, alcune
delle voci. Solido il Conte
d’Almaviva di Vito Priante. Forte, convinto,
assolutamente nella parte. Come tutto quanto
il resto del cast (di cui si può dire solo
bene), preparatissimo. Molto bene anche
Giorgio Caoduro, uno dei migliori Figaro che
abbia mai ascoltato. Potente e deciso, m’è
davvero piaciuto. José Maria Lo
Monaco è un Cherubino molto gradevole ed è
forse il suo personaggio che risente più di
tutti dell’assenza dei recitativi. Mi
sarebbe piaciuto apprezzarne la teatralità
in uno spettacolo completo. Di Giulia
Semenzato ho già parlato in diverse
occasioni tessendone le lodi. Qui è brava non
una, ma due volte. La prima perché
nonostante il raffreddore (colpi di tosse
durante le uscite per i ringraziamenti
finali danno la misura di quanto
l’indisposizione possa essere stata per lei
più che fastidiosa) ha cantato benissimo,
come di consueto. La seconda perché
Giulia Semenzato possiede quel talento
tipico di chi sulla scena sembra
praticamente esser nato e che – nonostante
gli acciacchi di stagione, che sono un vero
e proprio dramma nel dramma per la quasi
totalità degli interpreti lirici – riesce a
comunicare tutta quanta l’intensità ed il
calore del personaggio che interpreta. L’aria del quarto
atto Deh vieni non tardar è stata
cantata in modo sublime ed intrigante, e nel
finale Ti vo’ la fronte incoronar di
rose non nego che una lacrima
d’emozione m’è scesa. Perdonate, son
debolezze. Ma questo è quel che m’attendevo
da quella che considero, come già detto in
più occasioni, la voce migliore del mondo,
che neppure i malanni di stagione riescono a
sopraffare. Da qui si vedono
professionalità e bravura, preparazione e
dedizione frutto di anni di studio e
tenacia. Finora non mi sono
mai sbagliato nei miei giudizi. Posso dirlo
ad altissima voce. Applausi per
tutti, giustamente, alla fine dello
spettacolo. Indimenticabile
per mille ragioni. E passiamo alla
seconda inaugurazione, quella dell’Opera di
Roma, con il Simon Boccanegra di
Giuseppe Verdi. Qui il discorso si
fa diverso. Una messa in scena
estremamente sobria, a tratti essenziale,
con le scene ed i costumi di Antony McDonald
che possono da un lato rammentare il dipinto
metafisico di De Chirico Mistero e
malinconia di una strada (in cui
inizia e termina l’azione scenica) e
dall’altro riducono a quello che nelle
intenzioni vorrebbe essere un minimalismo
postbelllico anni Cinquanta del secolo
scorso i fastosi ambienti dogali genovesi,
sostanzialmente irriconoscibili, popolati
per lo più da camalli arrabbiati. Fatta
eccezione per una parte dei costumi dei
senatori, indossati su abiti da operai. Il
tutto in un’atmosfera cupissima, un po’
troppo lontana da quella marina brezza
cantata dal Boccanegra nella scena quinta
dell’ultimo atto. Qui della regia
posso parlare, lo spettacolo firmato
dall’inglese Richard Jones era completo. Un posto in un
palco di platea per l’ultima recita, quella
del 5 dicembre. Se devo dirla
proprio tutta, m’è parso che sia stato dato
largo spazio alla gestualità tipica ed alle
movenze tradizionali dei singoli interpreti,
che sono apparsi slegati dall’ambientazione
che la succitata scelta registica aveva
probabilmente in animo di fare. Insomma, sembra
che i cantanti abbiano avuto mano libera
nelle movenze, quasi fosse stata, in
sostanza, praticamente assente la regia
stessa. Faccenda diversa
per le masse corali e per i mimi, le cui
movenze sono state curate in tanti dettagli. Sono rimasto,
insomma, perplesso. Al contrario di quello
che ho visto appena due giorni dopo
nell’allestimento scaligero, di cui parlerò
in seguito. E dalla beata
solitudine (non capita spesso) del mio
palchetto di platea, ho potuto comodamente
valutare le buone, se non ottime prestazioni
della compagnia di canto. Su tutti,
ovviamente, Luca Salsi, che è un Boccanegra
possente anche da un mero punto di vista
scenico. Imponente, solido, centratissimo. Bravo da far quasi
paura, cavalca il palcoscenico con
sicurezza. Anni da protagonista assoluto in
vari teatri ne fanno il padrone del Costanzi
pure nell’ultima replica dello spettacolo
inaugurale. L’Amelia di
Eleonora Buratto risuona serena e piena, a
dispetto di una scelta costumistica che
avrebbe voluto essere neorealistica e si è
invece scontrata con un tipo di
abbigliamento in stile fin troppo fast
fashion. Brava l’interprete, che con
la voce ha cancellato quest’impressione
nello spettatore. Grandioso il
Fiesco di Michele Pertusi, che regge
ottimamente il confronto con Boccanegra.
Dire di più sarebbe sovrabbondante.
Affermiamo che è un piacere per l’udito del
melomane. Ed è nella parte
anche il Paolo di Gevorg Hakobyan, come pure
il Gabriele Adorno di Stefan Pop. Michele Mariotti
dirige l’orchestra dell’Opera di Roma con il
solito vigore a cui ci ha abituati (il
Mefistofele di Boito
dell’inaugurazione della scorsa stagione era
da incorniciare) ed il pubblico ha gradito
moltissimo, come il sottoscritto, la
complessiva tenuta orchestrale, che ha
mostrato un’omogeneità di suono
piacevolissima. Il finale vede
oltre cinque minuti di applausi o giù di lì
(non sono stato a contare, impegnato com’ero
a spellarmi le mani per esprimere la mia
soddisfazione), dapprima per il solo Salsi,
poi per il resto del cast e del solidissimo
coro del Costanzi. Passiamo quindi
all’ultima esperienza d’ascolto, quella
televisiva data da La forza del destino
di Giuseppe Verdi, che mancava dalla Scala
da un po’. La prima di
Sant’Ambroeus è un’istituzione. Non
solo per i milanesi. Difficilissimo
avervi accesso, se non lottando per avere un
tagliando d’ingresso (che è decisamente
caro, ma ne vale la pena) per poter poi
raccontare un giorno ai propri nipoti cosa
significhi lo spettacolo del 7 dicembre. Il loggionista
incallito, quello che va alla Scala quasi
esclusivamente per ascoltare e non
per vedere o farsi vedere sa cosa
voglia dire un avvenimento del genere. Non
paga migliaia di Euro, ma è disposto a fare
la fila al freddo per ottenere magari un posto
di solo ascolto. La Scala è per lui
qualcosa di molto simile ad un tempio, e
come tale lo rispetta. Il loggionista è una
leggenda. Taluni mi dicono che come figura pura
sia, diciamo così, scomparsa o quasi. Io mi auguro che
non sparisca mai. E comunque,
possiamo considerare il pubblico televisivo
una sorta di loggionista che assapora il
gusto dell’evento comodamente da casa. Non è la stessa
cosa, beninteso. Ma con le moderne
tecnologie è quasi come essere sul posto,
almeno per quanto riguarda l’ascolto. Nonostante
l’assenza della star Jonas Kaufmann,
annunciata dallo stesso per motivi familiari
il 19 novembre, lo spettacolo si
preannunciava come qualcosa di memorabile. E
così è stato. Già la mattina
dell’8 dicembre, dopo la prima, controllando
sul sito web del teatro, tutte le repliche
sono state indicate come esaurite. Biglietti
finiti. Fuori dalla Scala,
come di consueto, le solite manifestazioni
di dissenso a fini politici. Da tempo ormai
immemorabile, il 7 dicembre c’è sempre da
protestare e da militarizzare il centro di
Milano. Che sia giusto o
sbagliato, ormai la cosa rientra nella
tradizione. Non c’è prima alla Scala senza
casino fuori dal Piermarini. Ed a forza di
sorbirsi proteste, più o meno politicizzate,
la gente comune sembra averci fatto il
callo. È come lo sciopero dei trasporti il
venerdì nelle grandi città. Se non c’è, è
come mancasse qualcosa. Ripeto, giusto
manifestare. Ma se lo si fa solo per partito
(è il caso di scriverlo) preso, allora non
fa più effetto. È solo mero disagio per il
comune cittadino costretto a chinare la
testa ed a subire. Non importa da dove venga
il mugugno. Alla fine, chi ci rimette è solo
il classico uomo della strada. Comunque, torniamo
alla musica. La regia,
efficacissima, porta la firma sensibile ed
intelligente di Leo Muscato, che
probabilmente memore di certi meravigliosi
allestimenti che si vedevano anni fa al
Teatro Sistina di Roma (a me piace
immaginare così la faccenda, ci sono musical
che hanno fatto la storia) ha organizzato il
materiale scenico su una piattaforma rotante
su cui si muovono i singoli personaggi e le
masse corali in modo da garantire una
spazialità visiva ed una pratica
organizzazione della scenografia, per certi
versi essenziale ma altamente simbolica,
curata dalla brava Federica Parolini. L’azione si sposta
dalla Spagna del Settecento e passa al
conflitto di trincea del ’15-’18 per poi
volare all’ultimo atto fino ai giorni
nostri, col tema portante della guerra che
nell’ultimo atto ci rammenta la tragedia dei
profughi di Gaza alla disperata ricerca di
aiuti e d’acqua potabile. O quella del
conflitto russo ucraino. Oppure la
situazione di tanti disperati in fuga dagli
scenari delle tante guerre regionali in atto
e di cui sentiamo parlare solo di tanto in
tanto. Smuovere le
coscienze. È quello che il teatro deve fare.
È ciò che la Scala ci ha rammentato in
quest’apertura di stagione, in questo
difficilissimo momento a livello
internazionale. E veniamo ai
protagonisti della serata. È stata, questa,
la migliore prima della Scala di Anna
Netrebko, che nei panni di Leonora riscuote
un successo meritatissimo. La soprano è in
stato di grazia come probabilmente mai prima
d’ora. Non sbaglia praticamente nulla e ci
regala un’interpretazione memorabile.
Applausi a scena aperta per un’artista su
cui erano puntati tutti i riflettori.
Successo pieno. Anche se qualche
contestazione di natura non musicale c’è
stata, per la nazionalità dell’interprete. Separate l’Arte
dalla politica, per favore. Non c’entra
niente. A teatro si va per
godere di un momento catartico. Se volete
protestare per altre ragioni, fatelo nelle
sedi opportune. Non confondiamo un
tempio della lirica con il bar dello sport. Non è proprio il
caso. Tornando a noi, mi
è piaciuto molto il Don Carlo di Ludovic
Tézier, la cui nobiltà di canto ed una
corposità vocale notevole vengono alla luce
in modo pieno. Il non facile
compito di sostituire Kaufmann è stato
affidato a Brian Jagde, che devo dire non ha
affatto sfigurato. Anzi. Note di merito per
la Preziosilla di Vasilisa Berzhanskaya e
per il Frate Melitone di Marco Filippo
Romano, per chiarezza d’interpretazione e
presenza scenica. Chailly è stato
visto sorridere, soddisfatto, sul podio. E non possiamo che
essere d’accordo. Nel suo insieme,
lo spettacolo è riuscitissimo. L’orchestra
risponde benissimo e la sinfonia, per dirne
una, è da incisione. Dodici minuti di
applausi, dopo il finale, rappresentano la
misura del trionfo. Bene. Concludo qui
il resoconto del trittico di inaugurazioni
di stagione che ho visto ed ascoltato. Tre momenti in cui ho potuto valutare ed apprezzare il lavoro e la passione di tanti interpreti che danno lustro e vita alla tradizione musicale che è una delle colonne portanti della cultura di questa nazione, che oggi più che mai ha bisogno di nutrirsi del bello per sollevarsi dal torpore per splendere come e meglio di prima. |
||
|
Gabriele Vitella |
||
| Note spettacoli: TEATRO REGIO DI TORINO 23 novembre - 1° dicembre 2024 “LE NOZZE DI FIGARO” di Wolfgang Amadeus Mozart personaggi e interpreti: Il conte d’Almaviva Vito Priante La contessa d’Almaviva Monica Conesa Figaro Giorgio Caoduro Susanna Giulia Semenzato Cherubino Josè Maria Lo Monaco Marcellina Chiara Tirotta Bartolo Andrea Concetti Basilio Juan José Medina Don Curzio Cristiano Olivieri Antonio Janusz Nosek Barbarina Albina Tonkikh Prima contadina Eugenia Braynova Seconda contadina Daniela Valdenassi Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino direttore LEONARDO SINI Regia Emilio Sagi Scene Daniel Bianco Costumi Renata Schussheim Regista assistente Matteo Anselmi Coreografia Nuria Castejon Maestro del coro Ulisse Trabacchin Allestimento Teatro Regio Torino Produzione originale Teatro Real (Madrid) In coproduzione con Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (A.B.A.O.) *** TEATRO DELL'OPERA DI ROMA 27 novembre - 5 dicembre 2024 “SIMON BOCCANEGRA” di Giuseppe Verdi personaggi e interpreti: Simon Boccanegra Luca Salsi Maria Boccanegra (Amelia) Eleonora Buratto Jacopo Fiesco Michele Pertusi Gabriele Adorno Stefan Pop Paolo Albiani Gevorg Hakobyan Pietro Luciano Leoni Ancella di Amelia Angela Nicoli Capitano dei balestrieri Michael Alfonsi Orchestra e coro del Teatro dell’Opera di Roma direttore MICHELE MARIOTTI Regia Richard Jones Scene e costumi Antony McDonald Luci Adam Silverman Coreografia per i movimenti mimici Sarah Kate Fahie Maestro d’armi Renzo Musumeci Greco Maestro del coro Ciro Visco Nuovo Allestimento Teatro dell’Opera di Roma *** TEATRO ALLA SCALA DI MILANO 7 dicembre 2024 - 2 gennaio 2025 “LA FORZA DEL DESTINO” di Giuseppe Verdi personaggi e interpreti: Il marchese di Calatrava Fabrizio Beggi Donna Leonora Anna Netrebko Don Carlo di Vargas Ludovic Tézier Don Alvaro Brian Jagde Preziosilla Vasilisa Berzhanskaya Padre guardiano Alexander Vinogradov Fra Melitone Marco Filippo Romano Curra Marcela Rahal Un alcade Huanhong Li Mastro Trabuco Carlo Bosi Un chirurgo Xhieldo Hyseni Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano direttore RICCARDO CHAILLY Regia Leo Muscato Scene Federica Parolini Costumi Silvia Aymonino Luci Alessandro Verazzi Coreografia Michela Lucenti Nuovo Allestimento Teatro alla Scala di Milano |
BACK TO / INDIETRO A
Tavola dei contenuti
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.
L’autore non ha alcuna responsabilità per i siti segnalati; il fatto che il blog fornisca questi collegamenti non implica l’approvazione dei siti stessi, sulla cui qualità, contenuti e grafica è declinata ogni responsabilità.
![]()
All rights reserved. Any
unauthorized copying or recording in any manner
whatsoever will constitute infringment of such
copyright and will render the infringer liable to an
action of law.
Tutti i diritti riservati. Qualsiasi tipo di copiatura
e registrazione non autorizzata costituirà violazione
del diritto d’autore perseguibile con apposita azione
legale.
Dimensioni video ottimali: 1024 x 768