Nel labirinto del teatro barocco, dove la parola si fa gesto e la musica diventa linguaggio dell’anima, le Tragedie Cristiane del 1729 occupano un territorio singolare e quasi mitologico: un esperimento che intreccia devozione e dramma, pedagogia gesuitica e raffinatezza napoletana, in un’epoca in cui il teatro musicale cercava una nuova identità morale e formale. Il progetto discografico pubblicato da Passacaille, affidato all’ensemble Stile Galante sotto la direzione di Stefano Aresi, restituisce vita e coerenza a un corpus disperso, a una concezione di teatro musicale che voleva conciliare l’affetto e la ragione, la parola sacra e la teatralità del corpo. L’album non si limita a raccogliere arie o frammenti: ricostruisce un modo di pensare la musica come rappresentazione dell’interiorità, lontana dai fasti dell’opera ma non meno appassionata nel suo slancio spirituale.
L’anno 1729, che dà il titolo al progetto, segna per il mondo napoletano una soglia di maturità. La cosiddetta “scuola partenopea” aveva ormai elaborato un linguaggio riconoscibile, fondato sull’equilibrio fra retorica e canto naturale, sul declamato che si piega alla grazia della melodia e sull’uso della dissonanza come strumento d’affetto. Tragedie Cristiane si inserisce in questo orizzonte, ma ne rivela anche la tensione sotterranea: quella di un’arte che cerca di conciliare la drammaticità dell’opera seria con un contenuto spirituale, non più didattico ma contemplativo. È qui che la raccolta si fa “esperimento teatrale”: un teatro della parola e del gesto, dove la fede diventa dramma e il dramma una forma di conoscenza.
L’approccio di Stefano Aresi e del suo ensemble è di una finezza musicologica rara. Non c’è in questa incisione la pretesa di “ricostruire” un evento perduto, ma di farne percepire la tensione viva. L’interpretazione non indulge mai al pittoresco né all’ornamento gratuito: l’ornato qui è linguaggio, non decorazione. Stile Galante — vero laboratorio di intelligenza collettiva — suona con un equilibrio che fonde chiarezza e passione, alternando leggerezza di tratto e densità timbrica, secondo una logica teatrale che affida ogni gesto al significato della parola. La registrazione si distingue per una trasparenza che consente all’ascoltatore di cogliere la trama sottile fra voce e basso continuo, fra arco e respiro, restituendo quella mimesis barocca dove tutto vive per analogia.
Le voci, accuratamente selezionate, incarnano la varietà affettiva del progetto. Ann Hallenberg porta nella sua linea un senso di gravità luminosa, una nobiltà del fraseggio che sa unire autorità e intimità. Il suo timbro scuro, controllato con sapienza, riesce a esprimere dolore e compostezza in egual misura, evitando il rischio della retorica. Francesca Cassinari, di timbro più chiaro e vibrante, restituisce la freschezza ingenua di certi personaggi moralmente puri ma non ingenui: la sua emissione nitida e il controllo delle mezzevoci offrono momenti di autentica sospensione teatrale. Valeria La Grotta, che qui torna dopo altri successi, contribuisce con un canto disciplinato e luminoso: la sua voce si muove come un’arpa che modula la parola in oro, con una misura che evita ogni eccesso patetico. È un’arte del controllo, dove la tecnica diventa trasparenza, e l’emozione si affida alla purezza del suono.
In questo quadro, Giuseppina Bridelli si inserisce con un profilo di singolare consapevolezza, capace di trasformare il recitativo in un atto di pensiero. La sua voce, dal velluto caldo ma mai opulento, si modula come un respiro che accompagna il testo senza forzarlo, quasi lo meditasse in tempo reale. Bridelli non “recita” la tragedia, la contempla: restituisce alla parola la sua dignità sonora, e alla musica la capacità di dire l’indicibile. Nei suoi interventi più intensi — in particolare dove il dramma si arresta per far parlare il silenzio — mostra come il teatro cristiano del Settecento potesse farsi luogo di verità interiore, senza bisogno di clamori. È una prova di maturità e di misura, perfettamente coerente con la visione interpretativa di Aresi.
Ma il merito più profondo dell’incisione non risiede soltanto nella qualità dei singoli interpreti: è nell’idea stessa di “esperimento” che Aresi riattiva un’antica vocazione europea della musica. Ogni brano diventa un frammento di un discorso morale più ampio, dove la drammaturgia si costruisce per contrasti, secondo la logica barocca dell’“opposizione degli affetti”. La direzione, precisa e partecipe, evita ogni rigidità filologica: non c’è il desiderio di dimostrare, bensì quello di far vivere la parola nel tempo. Il gesto di Stefano Aresi è misurato, quasi invisibile, ma percepibile nella costante attenzione alla forma e al respiro: un’autorità discreta, che guida senza imporsi.
L’ascolto dell’intero cofanetto produce una sensazione di unità sorprendente, nonostante la varietà degli autori. Questo perché il progetto non si fonda sulla somma dei singoli brani, ma sulla loro relazione interiore: ogni aria, ogni recitativo, ogni brano strumentale contribuisce a un’unica architettura affettiva. Si avverte, in filigrana, l’eco di Durante, di Porpora, di Vinci, di Hasse, ma come figure che dialogano, non come presenze isolate. È un teatro della memoria, dove la pluralità diventa coerenza, e la musica assume la funzione di un commento morale.
Il suono di Passacaille, sempre attento alla resa naturale e alla profondità dell’immagine acustica, valorizza questo equilibrio. L’ambiente sonoro, mai artificiosamente riverberato, lascia emergere la consistenza dei timbri e la respirazione dell’ensemble. Si percepisce la volontà di restituire un’esperienza intellettuale e sensoriale insieme: un ascolto che educa l’orecchio alla sottigliezza. Anche l’apparato editoriale — note, libretto, traduzioni — è curato con la stessa sensibilità che guida l’esecuzione, trasformando il disco in un oggetto di studio oltre che di godimento estetico.
Da un punto di vista storico, Tragedie Cristiane si situa in quel momento in cui la musica sacra assume i colori del teatro e il teatro cerca nella fede una legittimazione morale. È un punto di contatto fra estetica e teologia, fra il corpo e la grazia. L’idea di tragedia cristiana, nata in ambito gesuitico, si fa qui laboratorio di umanità: i personaggi non sono più modelli astratti di virtù o colpa, ma figure attraversate dal dubbio, dal desiderio, dalla consapevolezza del limite. La musica traduce tutto questo in gesti sonori di rara intensità, e l’esecuzione di Stile Galante restituisce quella complessità con una chiarezza che commuove più dell’enfasi.
In termini estetici, l’esperienza dell’ascolto invita a una riflessione più ampia sulla funzione della musica barocca oggi. Non si tratta di rievocazione o di puro filologismo: è un atto di pensiero. Riportare alla luce queste Tragedie Cristiane significa ricordare che l’arte non è solo bellezza, ma conoscenza mediata dal tempo, e che il suono antico continua a interrogarci sul presente. In questo senso, l’operazione di Passacaille si inserisce nella linea di una riscoperta che è anche una scelta etica: ridare voce a un passato che parla la lingua del futuro, restituendo alla musica la sua funzione meditativa.
Nel corso dell’ascolto, ciò che colpisce non è tanto la diversà dei compositori, quanto la continuità dello spirito. È come se ogni autore avesse contribuito a un’unica visione: quella di un teatro interiore, dove la grazia si fa dramma e il dramma diventa preghiera. Stile Galante traduce questa visione in una materia sonora limpida, coerente, attraversata da un’intelligenza collettiva che ricorda la pratica cameristica più pura. È un esempio di come la filologia possa farsi emozione, di come la precisione tecnica possa coincidere con la poesia.
Alla fine resta un’impressione di equilibrio, di luce controllata. Tragedie Cristiane è un viaggio nel tempo e nella coscienza, un teatro dell’ascolto più che della vista. Ogni nota sembra chiedere silenzio, ogni pausa diventa una forma di preghiera laica. Non c’è retorica, non c’è monumentalità: solo la misura del vero. E in questa misura si riconosce la mano di Stefano Aresi, l’arte matura dei suoi interpreti e l’intelligenza di un progetto che restituisce alla musica il suo compito originario: rivelare l’uomo a sé stesso.
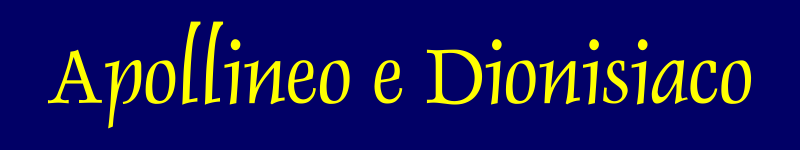
![]()