Nel tempo lungo della musica europea, dove ogni secolo riformula il proprio linguaggio come un modo di pensare e di respirare, Alessandro Scarlatti è il punto in cui la forma diviene coscienza e la coscienza diviene canto. La sua opera non è soltanto la genesi di una scuola, ma l’atto di fondazione di una misura nuova del mondo sonoro: un equilibrio che nasce a Napoli, tra la severità della tradizione contrappuntistica e il fervore teatrale di un popolo che trasforma la parola in gesto e il gesto in sentimento. In lui la musica italiana del Seicento compie la sua trasfigurazione, passando dalla retorica affettiva di Carissimi e Cavalli alla struttura organica che annuncia Haydn e Mozart. “Egli fu il più grande maestro d’Italia”, scriveva Charles Burney nel 1773 nel suo General History of Music, “poiché nessuno prima di lui aveva dato tanta chiarezza all’armonia e tanta nobiltà al canto.” Ma la chiarezza, in Scarlatti, non è mai riduzione: è luce che attraversa la complessità, ordine che non cancella il pathos ma lo rende intelligibile. È l’idea greca del metron, riflessa nella voce di un’epoca che si affranca dal manierismo e scopre la responsabilità della forma.
La Napoli che lo accolse nel 1684 come maestro della Cappella Reale era un crocevia di tensioni e splendori. Mentre la città viveva la contraddizione di una magnificenza cortigiana e di una povertà diffusa, i conservatori formavano generazioni di musicisti destinati a popolare le cappelle d’Europa. In questo ambiente, Scarlatti costruì la grammatica di un linguaggio tonale che avrebbe irradiato la modernità. I suoi oratori, le sue cantate, le sue opere non nascono per esaltare la gloria del potere, ma per indagare la voce umana come teatro interiore. La sua arte sta nella precisione del disegno e nella libertà che vi si nasconde: come se la forma, anziché imprigionare l’emozione, la purificasse dandole direzione. In ciò risiede il suo genio, e forse anche la sua solitudine. Perché mentre l’Europa guardava a Lully e a Corelli, egli edificava un linguaggio personale che non apparteneva né alla corte né alla piazza, ma a un regno dell’ascolto.
Dalla Griselda al Mitridate Eupatore, il suo teatro non è mai puro spettacolo, ma dramma morale. I recitativi accompagnati, che Händel avrebbe poi portato a Londra, nascono con lui come strumenti di introspezione. Il personaggio scarlattiano non si muove: medita, si ferma, ascolta la propria voce. In quelle pause in cui il basso continua a vibrare e la melodia si sospende, c’è la nascita di una psicologia musicale. E tuttavia la disciplina non cede mai all’astrazione: il pathos è contenuto, ma mai negato. La sua da capo aria, con la ripresa variata e la fioritura come esegesi, diventa la forma più perfetta dell’autocoscienza barocca. “La ripetizione”, scrive Johann Mattheson nel Der vollkommene Capellmeister (1739), “non è mera copia, ma riflessione del sentimento nel suo specchio armonico.” Scarlatti lo aveva intuito mezzo secolo prima: la ripresa non è ritorno ma tempo che si piega su sé stesso, come memoria viva.
Non vi è nulla di meccanico in questa costruzione. Ogni cadenza ha la necessità di una frase latina, ogni modulazione la precisione di un pensiero sillogistico. È l’eredità del suo studio romano con Giacomo Carissimi e con Francesco Foggia, ma anche di quella severità che egli muta in eleganza, trasportando nel melodramma la chiarezza dell’oratorio. Nei suoi lavori sacri — Caino overo Il primo omicidio, Il primo pentimento di Adamo, La Santissima Trinità — la forma è già dottrina teologica: non decorazione della fede, ma incarnazione della misura divina. La polifonia non è più un tessuto medievale, ma un dialogo di coscienze. Dietro le sue fughe si percepisce l’eco della metafisica della luce che la cultura napoletana, attraverso Tommaso Campanella e la filosofia naturale, aveva consegnato al Seicento: l’idea che la bellezza sia un ordine dell’intelletto. E così, nella musica di Scarlatti, la grazia non è sentimento ma conoscenza.
Quando le Sinfonie di concerto grosso furono copiate e diffuse in Germania, Johann Sebastian Bach le studiò come modelli di chiarezza e proporzione. Non vi è prova diretta di un’influenza personale, ma Carl Philipp Emanuel Bach, nelle sue lettere del 1775, scrive che “la scuola napoletana di Scarlatti aprì all’Europa il linguaggio del cuore e della ragione”. È un riconoscimento postumo, ma giusto. La stessa Vienna che genererà Haydn e Mozart è già predisposta dal seme scarlattiano: l’idea di una forma che pensa da sé, che non è somma di parti ma organismo vivente. Carl Dahlhaus, nella sua Estetica della musica (1979), definisce questo passaggio come “il momento in cui la composizione diventa riflessione del tempo nel tempo stesso”. La definizione vale per Beethoven, ma nasce con Scarlatti, che per primo concepisce la musica come architettura temporale.
Non c’è nulla di astratto, in questa architettura. Scarlatti conosce la voce umana come un corpo: ne misura la fatica, la tensione, il respiro. La sua scrittura vocale è un atto d’amore verso la parola, non un esercizio di virtuosismo. Egli educa la voce a dire la verità del sentimento, ma sempre entro la linea del decoro. In questo senso, la sua arte è profondamente apollinea: la misura domina il fervore, ma senza spegnerlo. “Non bisogna credere”, scriveva Fedele d’Amico nel suo saggio del 1967 dedicato ai maestri napoletani, “che la compostezza di Scarlatti sia freddezza: è la consapevolezza che la passione, per essere vera, ha bisogno di una forma.” Ecco la lezione morale del barocco musicale: l’intensità senza disordine, l’emozione che si fa linguaggio.
Le sue opere si muovono in uno spazio di equilibrio continuamente minacciato dal caos. La melodia sale come un pensiero che cerca la propria altezza, e il basso, nel suo moto regolare, la trattiene come la ragione trattiene il desiderio. In questa dialettica di tensione e misura si prefigura tutta la storia successiva della musica occidentale: l’inquietudine del soggetto romantico che nasce dal seno stesso dell’ordine barocco. Nietzsche, nella Nascita della tragedia, riconoscerà nella musica il campo di battaglia fra Apollo e Dioniso. Scarlatti, due secoli prima, aveva già incarnato questa contesa nella sua pratica quotidiana di compositore. La sua linea melodica è apollinea, ma la sua armonia è dionisiaca: un sottosuolo febbrile, un respiro tellurico che muove le fondamenta del canto. Se il classicismo viennese è la riconciliazione di queste forze, il barocco napoletano è la loro rivelazione originaria.
Ciò che sorprende, oggi, nel riascoltare Il Mitridate Eupatore o La Griselda, è la modernità del ritmo drammatico. Scarlatti non conosce ancora la forma-sonata, ma ne possiede l’intuizione emotiva: l’idea che un conflitto tematico possa risolversi attraverso la modulazione e la ricapitolazione. La sua musica è già “processuale”, direbbe Theodor W. Adorno: non semplice successione di affetti, ma percorso dialettico. Ogni aria è un microcosmo, una parabola che si chiude su sé stessa senza cessare di significare. La perfezione di questa costruzione non è mai arida, perché dentro di essa scorre la vita. La vitalità di Scarlatti è quella di chi conosce la finitezza del tempo e la trasforma in ritmo. Nella sua musica il tempo non è ciò che passa, ma ciò che misura: un respiro che si fa coscienza.
Quando egli morì nel 1725, l’Europa era già diversa. A Lipsia, Bach stava scrivendo la Passione secondo Matteo; a Venezia, Vivaldi pubblicava le sue ultime raccolte; a Vienna, un giovane Fux insegnava le regole del contrappunto che Scarlatti aveva già reso poesia. Eppure, nel silenzio della sua morte napoletana, si chiudeva un secolo e se ne apriva un altro. Non lasciò discepoli diretti, ma lasciò un sistema. Francesco Durante, Leonardo Leo, Nicola Porpora, Giovanni Battista Pergolesi: tutti, in modi diversi, bevvero alla sua fonte. Persino Händel, passando da Napoli nel 1707, ne ascoltò la musica e ne portò l’impronta a Londra. “La maniera di Scarlatti”, scrisse in una lettera a Telemann del 1711, “è come un parlare nobile che non ha bisogno d’alzare la voce.”
Tre secoli dopo, quel parlare nobile è ancora la misura con cui giudichiamo la dignità della musica. Laddove la modernità ha frantumato la forma e l’ha dispersa nel rumore, Scarlatti ci ricorda che la forma è la più umana delle discipline, perché nasce dall’ascolto. Ascoltare significa misurare il tempo con rispetto, accettare il limite come luogo della libertà. Ogni sua aria è una meditazione sul limite, ogni fuga un tentativo di ordine in mezzo al caos. Egli conosce la malinconia del pensiero che sa di dover morire, e la trasforma in bellezza. In questo, Scarlatti è il primo musicista moderno: non perché anticipi il futuro, ma perché lo comprende.
Nella luce obliqua del suo tricentenario, ciò che resta non è soltanto la grandezza di un maestro, ma la percezione che la musica, grazie a lui, abbia imparato a pensarsi. Le sue sinfonie, le sue cantate, i suoi oratori non sono reliquie di un’epoca perduta, ma frammenti di un sapere che ancora ci riguarda: la convinzione che la bellezza sia un atto morale. Come scrisse Paul Valéry, “la forma è la faccia della sostanza quando essa ha raggiunto la coscienza di sé”. Scarlatti questa coscienza la possedette intera, e la consegnò al mondo sotto forma di canto. E forse nessuna definizione rende meglio la sua grandezza che quella, semplice e vera, di un anonimo copista napoletano che trascrisse un suo oratorio: “Musica di Scarlatti, che parla come un’anima in pace con Dio.”
Eppure, nonostante la sua centralità, Alessandro Scarlatti rimane ancora oggi una figura circondata da un alone di silenzio. La sua grandezza è stata spesso occultata dalla fama del figlio Domenico, che la posterità ha preferito per la sua modernità pianistica, dimenticando che la libertà di quel linguaggio nasceva dal rigore paterno. In realtà, tra i due esiste un legame non solo di sangue ma di visione: la stessa tensione verso l’unità del pensiero musicale, la stessa volontà di trasformare la tecnica in atto poetico. Domenico aprì la tastiera all’Europa, Alessandro aprì l’anima alla musica. Il figlio tradusse in virtuosismo ciò che il padre aveva pensato in architettura. Entrambi furono costruttori di labirinti: uno nello spazio, l’altro nel tempo.
In questa prospettiva, il tricentenario della sua morte non è soltanto un atto di memoria, ma un’occasione per riflettere sul significato della forma come atto etico. In un secolo dominato dalla frammentazione e dalla perdita del centro, Scarlatti ci restituisce la nostalgia dell’unità. Non quella falsa e retorica delle accademie, ma l’unità che nasce dall’armonia delle differenze. Le sue opere, lette oggi, parlano con un linguaggio di straordinaria attualità: ogni linea melodica è un equilibrio fra tensione e quiete, fra il desiderio di espandersi e la necessità di tornare al principio. Come nella vita, ogni fuga ritorna al tema, ogni errore cerca una risoluzione. In lui, la musica è la più limpida immagine dell’etica: non comanda, ma persuade.
Nella Griselda del 1721, ultimo suo capolavoro teatrale, l’eroina sopporta le prove imposte dal marito con una pazienza che non è rassegnazione ma consapevolezza. Scarlatti ne fa un simbolo del sacrificio come conoscenza: la voce che soffre diventa sapienza. Nulla è più lontano da lui della retorica tragica o dell’enfasi del virtuosismo; la sua tragedia è composta, come se la pietà cristiana si fosse fatta stile. La sua musica è un atto di equilibrio morale, una lezione sulla misura. Laddove altri compositori del suo tempo cercavano la sorpresa, egli cercava la verità del sentimento.
Nessuna arte come la musica sa esprimere la misura dell’uomo di fronte all’infinito. Scarlatti lo aveva intuito, e ne aveva fatto la sua religione. Nei suoi oratori, la fede non si manifesta nell’eccesso ma nella chiarezza: la divinità parla per proporzione. Si può dire che in lui l’architettura divina e quella musicale coincidano. La fuga, nella sua scrittura, è una meditazione sulla coesistenza dell’unità e della molteplicità: ogni voce si muove indipendentemente, ma tutte convergono verso un unico punto di luce. È un’immagine teologica, ma anche umana: la pluralità che tende all’accordo. Non è forse questa l’essenza stessa dell’armonia, la più metafisica delle parole nate dal mondo sonoro?
Quando Carl Philipp Emanuel Bach parlava di “linguaggio del cuore e della ragione”, forse pensava a questa unità. Perché la musica di Scarlatti, pur nata in un’epoca ancora dominata dal dogma, è già laica nella sua profondità. Essa parla dell’uomo prima che del cielo, e nel suo rigore troviamo un senso di dignità che nessun romanticismo avrebbe più potuto restituire con altrettanta serenità. La modernità ha spesso confuso la libertà con la dispersione; Scarlatti ci ricorda che la libertà vera è dentro la forma, non fuori. La regola, per lui, non è una prigione ma un varco. Nella disciplina del contrappunto vive la più alta idea di libertà spirituale: quella che nasce dal rispetto per la legge armonica.
Ascoltando oggi una sua cantata, come Bella madre de’ fiori, o una sinfonia di apertura, si percepisce un senso di levità che non appartiene più al tempo ma alla mente. È la levità di chi conosce la fatica del mondo e tuttavia sceglie la bellezza come risposta. Scarlatti non costruisce cattedrali sonore, ma templi interni. La sua musica è come la pietra pomice dei golfi napoletani: porosa, leggera, ma incandescente nel profondo. Il fuoco che la attraversa è la consapevolezza della morte, la coscienza che ogni forma è effimera e che proprio per questo merita di essere perfetta.
La Napoli di Scarlatti era una città in cui la miseria e la magnificenza convivevano come due voci di uno stesso coro. Nelle chiese risuonavano i motetti dei suoi allievi, nei teatri le sue opere; ma dietro l’apparenza del fasto si celava una tensione civile. Il barocco napoletano è sempre stato anche politico: la bellezza come resistenza, la misura come opposizione al disordine. In questo senso, Scarlatti fu non soltanto un artista ma un legislatore dell’anima. Il suo rigore formale è un atto di pietà verso il mondo, una risposta alla disarmonia della vita sociale e spirituale del suo tempo.
La posterità non gli ha reso giustizia, perché la sua grandezza non si misura con il clamore. Egli non cercò il pubblico, ma l’ascolto. E l’ascolto, nel nostro tempo, è diventato un atto rivoluzionario. Ascoltare significa rallentare, misurare il tempo con il cuore, ritrovare la pazienza del significato. In questo gesto — apparentemente semplice — si racchiude l’intera etica scarlattiana. Tutta la sua musica è un invito a riconciliare l’uomo con il tempo. Nel frastuono del presente, ricordarlo significa riconoscere che ogni civiltà comincia dall’attenzione.
Non è un caso che la musicologia moderna, da Fedele d’Amico a Carl Dahlhaus, abbia riscoperto Scarlatti non come un “precursore”, ma come un compimento. “Con lui — scrive Dahlhaus — la musica italiana raggiunge la sua maturità dialettica: l’unità di forma e contenuto non è più un ideale, ma una realtà operante.” Questo giudizio, tanto sobrio quanto profondo, restituisce la verità di un autore che non ha bisogno di aggettivi. In un’epoca che idolatra l’innovazione, egli ci insegna che l’originalità più alta è la fedeltà alla verità interiore.
Forse è per questo che la sua musica, pur così luminosa, è percorsa da un’ombra di malinconia. Non la malinconia dell’artista incompreso, ma quella del sapiente che conosce la fragilità del proprio sapere. Scarlatti sa che ogni armonia è provvisoria, che ogni equilibrio è una tregua. Il suo genio sta nel trasformare questa consapevolezza in serenità. La serenità di chi, contemplando l’instabilità del mondo, sceglie di rispondere con la bellezza. Non vi è rassegnazione, ma un senso superiore del limite: la consapevolezza che il limite stesso è la condizione della grazia.
Il suo esempio ha ancora qualcosa da insegnarci. In un’epoca in cui la musica rischia di dissolversi in puro consumo, Scarlatti ci invita a tornare al significato originario dell’arte: rendere il tempo abitabile. Ogni sua composizione è un microcosmo di ordine, un laboratorio di equilibrio. Ascoltarlo oggi significa ritrovare la misura perduta, quella capacità di pensare per proporzioni che la modernità ha smarrito. Come scrisse Luigi Pareyson, “la forma è il modo in cui la libertà diviene visibile.” Scarlatti, con le sue mani pazienti e la sua mente chiara, fece della libertà un’arte visibile.
Non sappiamo se nella sua ultima sera, a Napoli, egli ascoltasse ancora in sé le voci delle sue opere. Ma possiamo immaginare che nel silenzio del tramonto, fra il profumo del mare e il rintocco delle campane, la sua mente avvertisse la stessa pace che la sua musica ha saputo custodire. Il tempo, per lui, non era un nemico ma un compagno: un fluire ordinato in cui la memoria e il futuro si toccano. Per questo la sua arte non invecchia. Essa è sempre attuale perché parla dell’eterno nel linguaggio del finito.
Tre secoli dopo, ogni volta che un direttore solleva la bacchetta per riaccendere le sue note, la storia si rinnova. Non vi è celebrazione più degna del suo nome che la semplice esecuzione di una sua opera, l’atto puro dell’ascolto che ricrea la forma nel presente. “La musica non muore — scrisse Ferruccio Busoni — perché è essa stessa la materia del tempo.” In Scarlatti questa materia trova la sua geometria perfetta. Egli non ci ha lasciato monumenti di pietra, ma architetture d’aria. E in quell’aria continua a vivere, come un soffio che attraversa i secoli.
Ascoltarlo oggi, nel tricentenario della sua morte, significa riconoscere che la musica non è un linguaggio del passato, ma una forma di conoscenza ancora viva. Scarlatti ci parla non da un secolo remoto, ma da una regione dell’anima che è sempre presente. La sua lezione è che la bellezza non è un lusso, ma un modo di comprendere. Nel suo silenzio operoso si riflette la più alta idea di civiltà: quella che trasforma il rigore in grazia, la scienza in umanità, la misura in luce.
In questo senso, egli non appartiene al Barocco, ma all’eternità. La sua musica è la dimostrazione che il tempo può essere vinto non con la forza, ma con l’armonia. Ogni accordo che chiude una sua aria, ogni cadenza che si posa come una promessa mantenuta, è una vittoria sul disordine. E in quella vittoria, così discreta e assoluta, si riconosce la grandezza dell’uomo.
“Chi vuole comprendere l’ordine del mondo — scrisse Hegel nelle Lezioni di estetica — ascolti la musica, perché essa è il pensiero che non ha bisogno di parole.” Se queste parole valgono per l’arte in generale, in Scarlatti esse trovano la loro incarnazione più pura. Il suo pensiero non aveva bisogno di parole perché era già parola fatta suono. In ogni sua pagina si compie la riconciliazione fra intelletto e sensazione, fra l’umano e il divino.
Così, nel silenzio che segue l’ultima nota di un’orchestra che esegue il Caino overo Il primo omicidio o la Santissima Trinità, sembra di udire non la fine, ma un respiro che continua. È il respiro stesso del tempo, disciplinato dalla forma e insieme liberato dalla grazia. In quel respiro si riconosce la voce di Alessandro Scarlatti, architetto dell’armonia, inventore della forma, testimone dell’ordine possibile tra caos e luce.
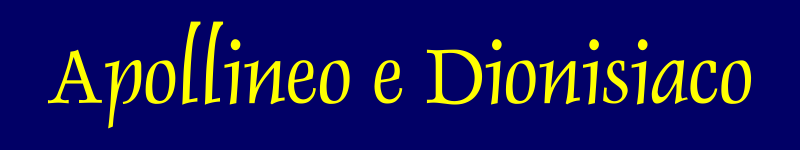
![]()