© Gabriele Vitella
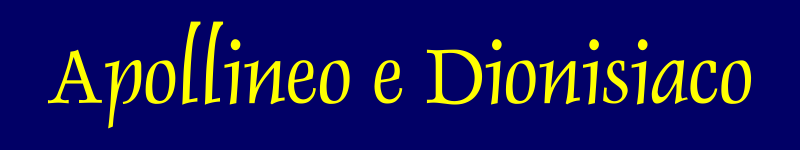
Un blog che vuol essere un caffè con le Muse.
Senza l’Arte non potremmo essere vivi.
| 27 Dicembre 2025 |
||
|
Dentro la clausura, fuori dal silenzio |
||
|
1. la voce vietataNell’Europa del Seicento, la voce femminile si trovava sospesa tra sacralità e interdizione, tra il canto che eleva e il corpo che seduce. Nessun ambito rende questa tensione più visibile – o meglio, più udibile – di quanto accada nei conventi italiani, dove centinaia di suore, obbligate alla clausura, esercitavano quotidianamente l’arte musicale. Non semplicemente come esecutrici, ma, in alcuni casi straordinari, come compositrici, maestre di coro, copiste, autrici di repertori sacri originali, la cui complessità contrappuntistica e la ricchezza affettiva nulla hanno da invidiare ai più noti nomi maschili coevi. Eppure, di queste musiciste si è saputo poco, o nulla, per lunghi secoli. Le loro opere sono rimaste spesso manoscritte, conservate in archivi monastici, non destinate alla stampa né alla diffusione pubblica. Nei casi in cui vennero pubblicate – come per Caterina Assandra o Chiara Margarita Cozzolani – le edizioni furono mediate da figure maschili (confessori, protettori, stampatori) e inquinate da strategie di “normalizzazione” che dissimulavano l’eccezione di una voce compositrice femminile. Non era solo una questione di genere, ma di potere sulla voce. Secondo le disposizioni tridentine e le prassi successive diocesane, le religiose dovevano vivere in separazione completa dal mondo, non solo fisica ma anche sonora. Le grate, i cori invisibili, le pareti divisorie avevano il compito non solo di proteggere le suore, ma anche di contenere la loro voce. Non si doveva vedere chi cantava, e in molti casi non si doveva neppure sapere cosa cantava. La voce femminile, anche quando indirizzata a Dio, non era considerata neutra: aveva un potere che andava sorvegliato. È significativo che molte di queste musiche fossero scritte non per la polifonia astratta, ma per voci reali di sorelle viventi, all’interno di spazi acustici precisi, in cui ogni nota risuonava in una relazione di prossimità, di devozione, ma anche di corpi e di tensioni. Quando un coro di monache si esibiva, la comunità maschile ascoltava senza vedere. L’esperienza era sensoriale e ambigua, a metà tra il sacro e il perturbante. Questo saggio si propone di ricostruire il mondo sommerso delle compositrici di convento attive nell’Italia del XVII secolo, non in chiave celebrativa, ma criticamente documentata, attraverso lo studio delle fonti musicali, delle strutture ecclesiali che ne regolarono la produzione, e delle strategie di resistenza linguistica e formale messe in atto da queste donne. Al centro, sta una domanda semplice ma essenziale: cosa significa comporre musica sacra da una condizione di reclusione, in un mondo in cui il tuo stesso suono è oggetto di controllo? La risposta non è solo storica, né solo estetica. È politica nel senso più profondo: riguarda la costruzione del soggetto, la tensione tra interiorità e norma, tra creazione e istituzione. Come ha scritto Suzanne Cusick, tra le voci femminili del Seicento e il nostro presente non esiste solo una distanza cronologica: esiste una frattura epistemica. Riaprirla significa ascoltare non solo la musica delle suore, ma anche il modo in cui essa fu taciuta.
2. Clausura e creazione: il convento come laboratorio sonoroNel cuore della civiltà barocca italiana, fra le pieghe delle città episcopali e dei centri minori, i conventi femminili rappresentarono un paradosso vivente: luoghi di segregazione e al contempo di straordinaria fioritura culturale, silenzi imposti da regole canoniche e spazi sonori pieni di voci, armonie, dissonanze, slanci creativi. Il concetto stesso di “clausura” – tanto evocato quanto raramente compreso nella sua dimensione concreta – non va inteso come mera interruzione del rapporto con il mondo esterno, ma come tecnologia spirituale e sociale volta a produrre un determinato tipo di soggettività femminile: obbediente, devota, ma anche ordinata, regolata, incanalata in un ordo amoris conforme alla visione maschile della salvezza. Dopo il Concilio di Trento (1545–1563), la clausura fu formalizzata con maggiore severità. Il decreto Circa reformationem monasteriorum (Sessio XXV, 1563) stabiliva che tutte le donne religiose, comprese quelle appartenenti a ordini precedentemente più attivi o semi-aperti (come le canonichesse), dovessero vivere in reclusione permanente, senza possibilità di uscire se non per gravissimi motivi e solo con l’autorizzazione del vescovo o del papa. Il fine dichiarato era duplice: preservare la purezza delle consacrate e garantire l’integrità della vita monastica. Ma l’effetto reale fu una ridefinizione profonda dello spazio femminile nella Chiesa postridentina: dallo spazio della carità visibile e dell’apostolato (ospedali, scuole, musica pubblica) allo spazio della interiorità controllata e del silenzio obbediente. Tuttavia, come sempre accade nei sistemi repressivi ben congegnati, l’interno della clausura si trasformò in un laboratorio formativo di altissimo livello, nel quale le giovani di buona famiglia – spesso educate sin dall’infanzia in ambienti monastici – ricevevano una formazione musicale, letteraria e religiosa estremamente raffinata. Il convento, lungi dall’essere luogo di semplice isolamento, divenne centro di produzione di cultura. E questa cultura si esprimeva soprattutto attraverso il suono.
Architetture del suonoI monasteri femminili italiani del Seicento, specialmente nei centri urbani maggiori (Milano, Bologna, Roma, Venezia), disponevano spesso di chiese monastiche biforcate: da una parte lo spazio riservato ai fedeli laici, dall’altra la zona destinata alle monache, separata da grate, gelosie, tende spesse, pareti traforate. In molti casi, il coro delle religiose era collocato in alto, dietro l’altare, o in una cantoria laterale inaccessibile allo sguardo del pubblico. Il suono, però, attraversava lo spazio: fluttuava, si propagava, talvolta si diffondeva addirittura con precisione ingegneristica. La grata acustica, elemento architettonico tanto simbolico quanto funzionale, costituiva una soglia permeabile: impediva la visione, ma non l’ascolto. In alcuni monasteri, la disposizione delle cantorie permetteva addirittura effetti stereofonici anticipatori, sfruttando il dialogo tra cori lontani e la risonanza degli archi voltati. L’orecchio, nella liturgia conventuale, diventava il senso privilegiato – l’unico ammesso – e la voce, invisibile ma pervasiva, acquistava una potenza quasi mistica. In questo contesto, l’esecuzione musicale da parte delle suore si caricava di una valenza ambigua: da un lato, rappresentava la più alta forma di devozione – un’offerta di sé a Dio, mediata dal canto sacro e dalla purezza della polifonia –, dall’altro, esponeva le monache al giudizio, al sospetto, all’accusa di esibizionismo spirituale o di seduzione mascherata da estasi. Vi sono casi documentati in cui i vescovi vietarono l’esecuzione musicale durante le festività per il timore che l’eccessiva bellezza delle voci femminili turbasse gli ascoltatori maschi, inducendoli in tentazione anche senza contatto visivo. La bellezza sonora, in quanto tale, diventava problematica.
Educazione musicale e ruoli interniMa chi insegnava musica alle suore? Come si formavano queste comunità musicali interne? Nonostante la clausura, molti conventi mantennero rapporti stabili con maestri esterni, spesso organisti di cattedrale o musicisti ecclesiastici di professione, che – con regole rigide di accesso e sotto stretta sorveglianza – impartivano lezioni settimanali, curavano l’accordatura degli strumenti, fornivano partiture. Le monache stesse, però, svilupparono una solida tradizione didattica interna, con figure come la maestra di coro, la copista, la responsabile del repertorio. In alcuni casi, queste donne erano vere e proprie compositrici. All’interno del convento, la musica non era un ornamento, ma una pratica quotidiana strutturata secondo le ore canoniche: Mattutino, Lodi, Terza, Sesta, Nona, Vespri, Compieta. Ogni ora aveva una sua funzione, una sua tensione tonale e spirituale. Le monache imparavano a leggere le notazioni quadrate, a comprendere la modalità gregoriana, a eseguire mottetti polifonici a due, tre o quattro voci, e in alcuni contesti anche a suonare strumenti (clavicembali, organi positivi, viole da gamba). La presenza di strumenti nelle chiese monastiche femminili è attestata, sebbene anch’essa soggetta a controllo: l’organo era ammesso, altri strumenti solo in occasioni speciali e con limitazioni. Questa prassi musicale quotidiana, fondata sulla ripetizione rituale e sull’ascolto collettivo, creava una memoria sonora condivisa. Non era solo musica: era formazione dell’anima attraverso il suono. In molte testimonianze d’epoca, emerge il valore spirituale attribuito alla polifonia: non mera arte, ma esercizio di armonia interiore e disciplina della volontà. La suora che cantava era anche una suora che interiorizzava l’ordine, il respiro, l’ascolto dell’altra, la sottomissione alla parte. Il coro come esercizio di kenosis.
Clausura come paradosso creativoIn questo quadro, la clausura si configura come paradossale motore creativo. Isolate dal mondo, private della vista dell’altro, le monache potevano esplorare con maggiore libertà forme di espressione poetica e musicale non finalizzate al consenso sociale. Nessun bisogno di compiacere un pubblico pagante, nessuna strategia di mercato, nessuna funzione mondana: solo il dialogo con il divino attraverso la forma. Ma questa forma – ben più libera di quanto si possa pensare – conteneva spesso tratti di audacia, di invenzione, di personalità. I mottetti di Cozzolani, i concertati di Vizzana, i ricercari di Assandra rivelano una piena consapevolezza delle risorse stilistiche del tempo e una capacità di inserirsi nel dibattito musicale coevo, seppure da una posizione marginale. La clausura, allora, non è solo privazione: è l’ambiente che rende possibile una voce diversa, una voce che, proprio perché non ascoltata socialmente, può essere più sincera, più interiore, talvolta più radicale. Non a caso, alcune delle compositrici di convento lasciano trapelare, tra le righe delle loro prefazioni o dei titoli dei mottetti, un sentimento di consapevolezza autoriale che sfida la retorica dell’umiltà. Il desiderio di essere ascoltate da Dio, certo – ma anche il desiderio di essere lette, copiate, tramandate. La composizione diventa così atto di memoria, ma anche di affermazione.
3. Le compositrici: voci dal silenzioL’immagine che la storiografia musicale ha tramandato del Seicento italiano è dominata da nomi maschili: Monteverdi, Carissimi, Frescobaldi, Cavalli, Rossi. Eppure, in quello stesso tessuto storico ed estetico, agivano – spesso in clandestinità culturale – numerose compositrici religiose, capaci di articolare un linguaggio musicale maturo, aderente alle più recenti innovazioni stilistiche, e insieme radicalmente personale. Le loro opere non furono frutto di ingenuità dilettantesca o di imitazione servile, ma espressione consapevole di un’identità spirituale e artistica che trovava nel convento – e nei suoi dispositivi di clausura – uno spazio singolare di creazione. A differenza delle poche donne laiche che poterono pubblicare grazie a mecenati o al favore delle corti (Barbara Strozzi, Francesca Caccini), queste suore composero all’interno di un sistema liturgico rigoroso, eppure seppero piegarlo a una voce propria, a volte persino visionaria.
Caterina Assandra (ca. 1590 – post 1618)Monaca benedettina del monastero di Sant’Agata a Lomello, in diocesi di Pavia, Assandra rappresenta una delle prime voci documentate di suora compositrice nella storia della musica occidentale. Formata a Milano sotto la guida di Benedetto Re, maestro della cattedrale pavese e figura di rilievo nella transizione dalla prima alla seconda pratica, Assandra fu profondamente influenzata dalle novità armoniche introdotte da Monteverdi e da Carlo Gesualdo. Nel 1609 pubblicò a Milano una raccolta di motetti con basso continuo per due e tre voci (Motetti a dua, e tre voci con basso continuo), stampata dagli eredi di Simon Tini e da Filippo Lomazzo. Il frontespizio riportava, con sottile ambiguità, il titolo “Donna Caterina Assandra Monaca professa”, segno di una volontà di autorappresentazione non scontata per una religiosa. I suoi mottetti mostrano una padronanza tecnica del contrappunto e una sensibilità armonica modernissima, con l’uso frequente di dissonanze espressive (sospensioni, ritardi, false relazioni) in funzione retorica. In brani come Duo Seraphim o Veni dilecte mi l’intervallo di sesta minore e i cromatismi sono impiegati come figure dolorose e appassionate, mentre l’intreccio imitativo costruisce veri e propri piccoli “drammi” interiori. Un altro elemento distintivo è l’uso calibrato del basso continuo, non come semplice fondamento armonico, ma come parte integrante dell’espressione affettiva. In diversi motetti si crea un dialogo serrato tra le voci superiori e il continuo, che sembra mimare il conflitto interiore dell’anima sotto scrutinio divino, alternando zone di tensione e di rilascio.
Chiara Margarita Cozzolani (1602 – post 1677)Figura di assoluto rilievo, Chiara Margarita Cozzolani fu monaca benedettina nel monastero di Santa Radegonda, adiacente al Duomo di Milano, dove ricoprì anche il ruolo di badessa. Il suo caso è particolarmente interessante non solo per la qualità musicale, ma per la documentazione diretta della sua attività e delle polemiche che suscitò. Tra il 1640 e il 1650 pubblicò tre raccolte di composizioni sacre:
Le fonti, oggi conservate in parte alla Biblioteca Ambrosiana e alla Biblioteca del Conservatorio di Milano, mostrano una maestria compositiva sorprendente. I suoi Salmi concertati a doppio coro fanno uso di tecniche policorali che si rifanno alla scuola veneziana, ma con una morbidezza tutta personale nell’intreccio delle linee vocali. Nel Laudate Dominum a otto voci, Cozzolani alterna sezioni omofoniche a passaggi imitativi, creando un effetto teatrale pur restando ancorata alla funzione liturgica. Le sue composizioni si collocano nella piena seconda pratica, con libertà di trattamento delle dissonanze, uso espressivo dei cromatismi e dinamiche affettive molto marcate. Ciò che colpisce, tuttavia, è l’intensità quasi “femminile” della scrittura: i testi sacri sono trattati con una dolcezza ardente, non remissiva, in cui la supplica si fa canto d’amore. Il Dialogo fra Maria e l’angelo, contenuto nei Concerti sacri, è un capolavoro di rappresentazione mistica: l’angelo e Maria sono entrambi cantati da voci femminili, in un intreccio di affetti che fonde teatralità e interiorità. Alcuni passaggi anticipano l’estetica del recitar cantando in ambito liturgico, con declamazioni melodiche su basso continuo e accenti sospesi sul respiro. Le autorità ecclesiastiche milanesi non furono insensibili a questa attività. Nel 1663 l’arcivescovo Alfonso Litta tentò di limitare le esibizioni pubbliche del coro di Santa Radegonda, ritenendole “inopportune per la condizione monastica”. Cozzolani difese con vigore l’onore musicale del convento, come attestano alcune lettere legate a quelle vicende, che oggi costituiscono una rara testimonianza di resistenza intellettuale e musicale femminile all’interno della Chiesa.
Lucrezia Orsina Vizzana (1590 – 1662)Nata a Bologna e entrata nel monastero camaldolese di Santa Cristina, Lucrezia Orsina Vizzana è forse la figura più tragica e intensa del panorama musicale conventuale secentesco. La sua unica raccolta pubblicata, Componimenti musicali de motetti concertati a 1 e più voci (1623), rappresenta un unicum: è l’unico libro stampato da una compositrice bolognese nel Seicento, ed è intriso di una violenta tensione affettiva. Le opere contenute – mottetti per 1, 2, 3 voci e basso continuo – mostrano tratti stilistici propri della scuola emiliana, ma con una libertà espressiva che rasenta il mistico. In un mottetto su Vulnerasti cor meum, ad esempio, l’uso insistito delle diminuzioni sulla parola vulnerasti crea un effetto di singhiozzo emotivo, un dolore che si fa melisma. Vizzana è anche famosa per lo scandalo che accompagnò la sua vita. Le cronache raccontano di lotte intestine nel monastero, accuse reciproche tra suore, ingerenze inquisitoriali. Una visita apostolica del 1628 documentò gravi “abusi” liturgici e comportamenti “scandalosi” legati alla musica: il sospetto era che le composizioni di Vizzana incitassero all’esaltazione affettiva, mettendo in crisi l’ordine. La sua musica, in altre parole, scardinava il silenzio prescritto. Dopo lo scandalo, la Vizzana non pubblicò più nulla. Secondo alcune testimonianze, verso la fine della vita avrebbe sofferto di disturbi mentali. Una conclusione tragica per una figura che aveva osato cantare il desiderio divino con voce propria, senza intermediazioni maschili.
Altri nomi, altre tracceAccanto a queste tre protagoniste, numerose altre religiose lasciarono tracce, spesso minime, di attività musicale:
Queste donne non fecero scuola nel senso tradizionale: non ebbero allieve celebri né scuole riconosciute. Ma la loro opera, oggi recuperata grazie a progetti filologici e musicologici specifici, rappresenta un capitolo essenziale della storia della musica sacra occidentale, non solo come testimonianza di eccezione, ma come prova di una pluralità di voci, rimaste per troppo tempo inascoltate.
4. Estetica e trasgressione: la forma come resistenzaAnalizzare la musica delle suore compositrici del Seicento significa attraversare un territorio di frontiera, dove l’arte si sovrappone alla spiritualità e la forma si carica di significati simbolici, etici, perfino politici. La struttura di un mottetto, la scelta di una dissonanza, l’uso di un certo lessico poetico o il trattamento di un intervallo non sono, in questi contesti, meri elementi tecnici: sono tracce di un pensiero incarnato, segnali di un’identità che prende forma nel suono e si manifesta in uno spazio controllato, ma non per questo passivo. Il cuore della scrittura musicale conventuale è il rapporto tra parola e voce, tra testo sacro e emissione sonora. A differenza di molte composizioni liturgiche maschili dello stesso periodo, che spesso trattano il testo con una certa astrazione formale, nei mottetti delle suore si avverte una tensione interna, un’urgenza affettiva che spinge la musica verso zone liminari: la parola viene abitata, scavata, talvolta quasi ferita dalla musica. È qui che la seconda pratica monteverdiana – con il suo principio della musica “serva all’orazione” – trova una declinazione specifica: la voce femminile, già censurata nella sua esistenza pubblica, viene sublimata come veicolo di senso totale.
Lessico poetico e ambiguità misticaUno dei tratti più sorprendenti nella produzione musicale delle suore è la scelta dei testi. Al di là del repertorio canonico (salmi, antifone, invocazioni mariane), emergono con forza componimenti ispirati al Cantico dei Cantici, testo biblico ampiamente adottato nella mistica postridentina, ma che – nella voce femminile – assume un’inedita pregnanza. Titoli come Vulnerasti cor meum, Osculetur me, Surge amica mea, Quae est ista quae ascendit non sono solo citazioni: sono dichiarazioni poetiche di desiderio. Il corpo dell’amato (che è Dio, ma anche immagine del corpo stesso della suora che desidera) è evocato, cercato, nominato con insistenza. Non si tratta di un linguaggio metaforico nel senso debole del termine, ma di una codificazione poetica dell’eros sacro, che attinge alla grande tradizione della mistica femminile. L’interpretazione di questi testi, nella composizione musicale, non è mai neutra. Le linee vocali si fanno sinuose nei passaggi più intensi, la melodia si spezza sulle parole che indicano ferita, abbandono, attrazione. Il verbo amare viene dilatato, i termini cor, vulnerasti, desiderium, lectulus sono musicati con attenzione estrema alla prosodia, quasi che il suono potesse restituire una profondità non dicibile. In Vulnerasti cor meum di Vizzana, per esempio, la reiterazione del verbo vulnerare è accompagnata da una progressione ascendente spezzata da pause inattese: il cuore trafitto non è semplicemente nominato, ma musicalmente colpito. Nel Osculetur me di Perucona, la dolcezza dei baci divini è resa da una catena di semicrome in eco tra due voci, quasi un inseguimento timido e devoto.
Dissonanza, respiro, corporeitàSul piano tecnico, la scrittura delle suore mostra un uso consapevole della dissonanza espressiva. Le regole della contrapposizione tradizionale (come tramandate dal Gradus ad Parnassum) sono rispettate, ma spesso tese fino al limite per rendere l’affetto del testo. Sospensioni ritardate, progressioni cromatiche, linee discendenti interrotte: tutti segnali di una musicalità “respirante”, dove il corpo – il respiro appunto – torna a farsi misura del tempo. Queste tecniche non erano nuove: le aveva usate Monteverdi, le avevano sviluppate gli affetti del madrigale tardo-cinquecentesco. Ma nella voce femminile, e soprattutto nella voce religiosa femminile, assumono un valore diverso. Ogni sospensione è anche una reticenza, ogni diminuzione è anche un singhiozzo, ogni passaggio ascendente è anche una invocazione. Nel Ego flos campi di Cozzolani, ad esempio, il confronto tra la “flos campi” e “lilium convallium” è reso attraverso l’opposizione di due gesti melodici: uno discendente, dolce, che fiorisce sul “flos”, e uno rapido, segmentato, più a scatti, sul “lilium”, con chiara intenzione pittorica. La voce non descrive, incarna. L’uso del respiro come articolazione affettiva è uno dei tratti più moderni di questa scrittura. Non si tratta di organizzare il fiato come mera necessità fisiologica, ma di usarlo come punto di cesura semantica, come pausa meditativa. Il silenzio fra due frasi non è assenza, ma parte del discorso. In questo senso, la scrittura musicale delle suore è anche una forma di poetica del corpo, che riafferma la presenza femminile anche laddove il corpo è ufficialmente negato, nascosto, rimosso.
Spiritualità e corporeità: Teresa, Cecilia, MariaQuesto intreccio tra musica e desiderio, tra forma e tensione affettiva, trova un suo antecedente e una sua giustificazione nella mistica femminile del Cinquecento e del Seicento. Santa Teresa d’Avila, figura centrale della riforma carmelitana, aveva già espresso il legame profondo tra amore divino e sensibilità corporale. Le sue estasi, spesso descritte in termini quasi erotici, furono per lungo tempo sospette, discusse, persino ridicolizzate dai teologi maschi. Nella musica delle suore, la stessa ambivalenza si traduce in suono. Le voci si cercano, si toccano senza mai incontrarsi. Il coro diventa luogo di una mistica corale, in cui la pluralità delle voci femminili costruisce uno spazio spirituale collettivo, non gerarchico, ma pulsante. In alcune composizioni, come nel O dulcissima Maria di Assandra, l’invocazione alla Vergine si conclude con una cadenza sospesa, che non chiude ma rimanda all’ascolto interiore. È un finale “non finale”, aperto, che richiama la logica della preghiera più che quella della retorica musicale. Santa Cecilia, patrona della musica, spesso figura ideale di riferimento, non è mai rappresentata come musa distante, ma come sorella interiore: la musica come pratica del cuore, non del prestigio. La stessa Maria, figura centrale nella devozione monastica, non è modello astratto di purezza, ma compagna di dolore, corpo da abbracciare, voce da imitare.
La forma come atto di libertà nascostaAlla luce di tutto questo, diventa chiaro come la forma stessa delle composizioni – il mottetto, la sonata, il concertato – si configuri come atto di resistenza. Non resistenza ideologica, non ribellione frontale: ma resistenza attraverso l’opera. Comporre secondo le regole per espandere i margini del dicibile, per portare dentro lo spazio liturgico una voce altra, irriducibile. Quando Cozzolani scrive a otto voci, non lo fa per esibizionismo policorale, ma per creare un teatro interiore dove ogni parte ha una voce, un’identità, una funzione affettiva. Quando Vizzana usa le pause improvvise e i salti melodici, non lo fa per impressionare, ma per tradurre il tremore spirituale. E quando Assandra armonizza i testi liturgici con audacia, lo fa per avvicinare il testo sacro alla propria esperienza umana, femminile, devota. In questo senso, la composizione non è solo un’abilità tecnica o un ornamento del culto: è una forma di memoria femminile attiva, un modo di imprimere sul pentagramma un’esperienza di clausura che non è solo isolamento, ma anche coscienza. Comporre musica, per queste suore, significava dare voce a ciò che non poteva essere detto.
5. Sorvegliare e punire: la voce sotto controlloNel sistema disciplinare della Chiesa postridentina, la voce femminile cantata era considerata oggetto di regolazione, non solo spirituale, ma giuridica. Non bastava che le religiose osservassero il silenzio fuori dalle celebrazioni, o che non si mostrassero in pubblico: anche ciò che poteva essere udito – e quindi desiderato, interpretato, ricordato – doveva essere vigilato, moderato, contenuto. L’azione repressiva non fu episodica, ma sistemica. Essa si manifestò attraverso visite apostoliche, decreti sinodali, lettere pastorali, regolamenti interni ai monasteri, spesso ispirati da un timore costante: che la bellezza della voce femminile potesse scardinare l’ordine dell’ascolto devoto e insinuare, anche senza volerlo, un principio di turbamento sensuale nel cuore dell’uomo. La voce, specie se invisibile, diventava pericolosa: perché non vista, era immaginata. E in quel vuoto, il desiderio trovava una soglia.
La sorveglianza come prassi ecclesiasticaLe visite apostoliche costituivano lo strumento principale attraverso cui i vescovi (o loro delegati) controllavano il rispetto delle regole monastiche. La musica era sempre oggetto di indagine. Nei verbali delle visite conservati in numerosi archivi diocesani (Milano, Bologna, Venezia, Roma), ricorrono formule come “le religiose cantano con troppo zelo”, “si fanno concerti durante le feste”, “si ode musica da più cori e con voci alte”, “si sospetta che alcuni motetti siano stati composti senza il parere del confessore”. Nel 1628, il cardinale Ludovico Ludovisi, legato pontificio per l’Emilia, visitò il monastero camaldolese di Santa Cristina a Bologna. Tra le accuse mosse alle monache: “si canta musica concertata che pare più da teatro che da chiesa”. Un’allusione diretta, evidentemente, a Lucrezia Orsina Vizzana, autrice dei Componimenti musicali stampati appena cinque anni prima. La risposta del monastero fu debole, e Vizzana – già provata da tensioni interne – scomparve dalla scena musicale. A Milano, l’arcivescovo Alfonso Litta scrisse nel 1663 al convento di Santa Radegonda, criticando l’uso di cori alternati e strumenti nelle feste solenni: “si ascoltano concerti tali da attirare il popolo più per il diletto musicale che per la pietà”. Ancora una volta, il bersaglio era l’eccellenza musicale del coro di Chiara Margarita Cozzolani, che proprio in quegli anni pubblicava i suoi Motetti a voce sola. Anche i confessori interni, spesso gesuiti o barnabiti, svolgevano una funzione di controllo: erano loro a decidere se una composizione potesse essere eseguita, se una stampa potesse essere autorizzata, se l’uso degli strumenti fosse lecito. Il parere spirituale diventava atto di censura preventiva. In alcune lettere private si trovano ammonimenti contro il “comporre senza umiltà”, o contro la “vanità di voler innovare la musica sacra con affetti mondani”.
Le accuse ricorrentiLe categorie principali attraverso cui si giustificava la censura erano sempre le stesse:
Le risposte (implicite) delle suoreDi fronte a queste pressioni, le suore non potevano rispondere con manifesti o lettere pubbliche. Ma le loro risposte stanno nella musica stessa. Nel modo in cui scegliendo il testo, orchestrando le voci, impostando la forma, esse rendevano visibile (o udibile) un pensiero. La forma compositiva diventava luogo di libertà obliqua, di risposta indiretta. Alcune opere mostrano segni espliciti di consapevolezza. Nei Concerti sacri di Cozzolani, l’intreccio tra cori crea una densità tale che la voce individuale si dissolve nel tutto: un modo per dire noi siamo una, senza bisogno di dichiararlo. In Vizzana, al contrario, ogni voce sembra singola, affettiva, quasi isolata: la resistenza come firma, non come coralità. Anche questo è discorso. E poi ci sono le pause, gli spazi vuoti, le sospensioni. Segni di una musica che conosce il rischio e lo trasforma in linguaggio. Le suore non potevano opporsi apertamente, ma potevano costruire un mondo sonoro che sfuggiva al controllo pieno dell’istituzione, che si manifestava nei dettagli, nelle curve melodiche, nei ritorni armonici inaspettati.
Il silenzio come forma di cancellazioneL’effetto della censura non fu solo contenimento: fu rimozione dalla memoria. Molte opere andarono perdute, non furono più eseguite, non furono copiate. Alcune compositrici – come Claudia Sessa – sono note solo per una o due opere. Altre, come Vizzana, vennero screditate, isolate, silenziate. La punizione non fu mai teatrale. Non ci furono roghi né scomuniche. Ma l’archivio stesso divenne strumento di castigo: non pubblicare, non copiare, non nominare. Per secoli, i nomi delle suore compositrici rimasero chiusi tra le mura dei monasteri, come se la loro voce – tanto più ascoltata, quanto più invisibile – non potesse trovare legittimazione nella storia. Oggi, riaprire quelle partiture significa anche guardare in faccia quella rimozione. Riconoscere che la musica sacra italiana non fu solo maschile, e che la voce delle donne, nel momento in cui veniva maggiormente repressa, seppe risuonare con forza inaudita.
6. La rimozione storiograficaIl silenzio che ha avvolto per secoli le suore compositrici del Seicento non è un semplice accidente archivistico. È il prodotto di una costruzione culturale consapevole, alimentata da criteri selettivi ben precisi: centralità maschile, visibilità pubblica, autorità istituzionale, presenza editoriale. Tutto ciò che esisteva al di fuori di queste coordinate – o peggio, contro di esse – è stato lentamente spinto ai margini del discorso storiografico, fino a scomparire quasi del tutto. Il canone della musica barocca, così come si è formato a partire dal Settecento e consolidato nei secoli successivi, si basa su una logica di presenza: è incluso ciò che è stampato, eseguito, tramandato da scuole riconosciute. Ma le suore non stampavano facilmente; non avevano allieve pubbliche; non disponevano di reti di committenza; e soprattutto, non firmavano sempre le loro opere. O, se lo facevano, lo facevano sotto pseudonimo, con formule vaghe, o attraverso l’intermediazione di uomini. È qui che si apre una questione centrale: l’autorialità femminile in ambito sacro non fu negata solo nella pratica, ma anche nel discorso. Per lungo tempo, i nomi delle suore non furono citati nei trattati, né nei dizionari, né nelle storie della musica. Nei grandi repertori della storiografia ottocentesca – da Fétis a Grove – il loro spazio è nullo o risibile. Quando compaiono, sono relegate a note marginali, con aggettivi ambigui: “devota”, “dotata”, “dilettante”. Questa rimozione non è solo un fatto quantitativo, ma qualitativo. Non si tratta di quante donne siano state ignorate, ma quale tipo di esperienza musicale è stato escluso dal racconto storico. Una musica che nasce da corpi non visibili, da voci non pubbliche, da rituali interni: una musica senza scena, senza spettacolo, senza protagonismo – e proprio per questo sospetta.
Canone e potereIl canone, come ha sottolineato Richard Taruskin, non è una somma di eccellenze, ma una narrazione di potere: ciò che entra nel canone risponde a una gerarchia di valori culturali che privilegia la figura dell’autore-genio, del compositore professionista, del produttore di opere riconoscibili e ripetibili. Le suore non corrispondono a questo modello. Esse componevano per necessità interna, per funzione liturgica, per devozione condivisa. La loro musica era radicata nella vita quotidiana del convento, e non progettata per la circolazione commerciale o teatrale. Per questo, anche quando veniva pubblicata (come nel caso di Cozzolani o Vizzana), essa non trovava facilmente accesso alle reti professionali della musica sacra. I destinatari erano pochi, la distribuzione limitata, la ricezione spesso ambigua. Senza un mercato, senza una committenza, l’opera femminile restava opaca al sistema musicale dominante. Inoltre, l’assenza di una trasmissione orale maschile – ovvero di maestri, teorici, allievi che ne citassero e tramandassero i nomi – contribuì all’oblio. Nessun Lully, nessun Padre Martini, nessun Burney incluse queste donne nei propri elenchi. Il canone si scriveva altrove. E il loro canto, per quanto spirituale, non era considerato Storia, ma pietà domestica.
Svolte critiche e riscoperta contemporaneaLa frattura comincia a incrinarsi solo nel secondo Novecento, grazie al lavoro delle prime studiose e musicologhe femministe. Figure come Suzanne G. Cusick, Marian Wilson Kimber, Laurie Stras, Anna Beer, Claire Fontijn – ciascuna da prospettive diverse – hanno contribuito a mettere in discussione la narrazione lineare della musica occidentale come prodotto esclusivo dell’autorità maschile. Particolarmente influente è stata Cusick, che ha proposto di leggere la musica delle suore non solo come repertorio da riscoprire, ma come “testo politico”: un luogo in cui si inscrive il corpo femminile negato, e che va interpretato attraverso categorie critiche nuove, capaci di integrare estetica, teologia, e teoria del genere. In parallelo, numerosi progetti di ricerca e di esecuzione hanno riportato in vita questi repertori. Tra i più importanti:
Anche in ambito accademico, convegni, tesi di dottorato e riviste specialistiche (come Early Music, Women & Music, Rivista Italiana di Musicologia) hanno iniziato a colmare le lacune. Ma il processo è tutt’altro che concluso. Molti manoscritti restano non trascritti, molti conventi custodiscono ancora fondi musicali non inventariati, e l’esecuzione delle opere si scontra spesso con resistenze pratiche e ideologiche. Il lavoro da fare non è solo filologico: è critico, culturale, simbolico.
Oltre la riabilitazione: verso il riconoscimento pienoImportante, infine, è evitare l’equivoco della “riabilitazione”. Non si tratta di “salvare” le suore compositrici come eccezioni da musealizzare, né di celebrarle in quanto donne nonostante tutto. Il loro valore non è nell’anomalia, ma nella profondità della loro opera. Esse non sono vittime da recuperare, ma soggetti culturali da riconoscere. Rimettere la loro musica in circolo significa ristabilire un’idea di storia musicale più ampia, dove la clausura non è assenza, ma altra presenza. Dove il silenzio imposto è contraddetto dal canto. Dove la voce non è più contenuta, ma finalmente ascoltata nella sua complessità. E in quella voce, ora come allora, si riconosce il respiro di un’intelligenza femminile collettiva, colta, creativa, capace di trasformare il limite in linguaggio.
|
||
|
Gabriele Vitella |
||
|
Per chi volesse approfondire l’argomentoFonti primarie e partiture moderne
Studi musicologici e storici
Approcci teorici e femministi
Registrazioni consigliate
ENGLISH VERSION |
BACK TO / INDIETRO A
Tavola dei contenuti
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.
L’autore non ha alcuna responsabilità per i siti segnalati; il fatto che il blog fornisca questi collegamenti non implica l’approvazione dei siti stessi, sulla cui qualità, contenuti e grafica è declinata ogni responsabilità.
![]()
All rights reserved. Any
unauthorized copying or recording in any manner
whatsoever will constitute infringment of such
copyright and will render the infringer liable to an
action of law.
Tutti i diritti riservati. Qualsiasi tipo di copiatura
e registrazione non autorizzata costituirà violazione
del diritto d’autore perseguibile con apposita azione
legale.
Dimensioni video ottimali: 1024 x 768