Nel panorama della direzione d’orchestra italiana, Beatrice Venezi occupa un posto singolare. È giovane, determinata, visibile, e si muove con disinvoltura tra il repertorio lirico, la divulgazione culturale e il dibattito pubblico. In un Paese che tende a difendere le proprie roccaforti estetiche, la sua figura — spesso più discussa che analizzata — finisce per diventare un terreno di riflessione più ampio: su cosa oggi significhi essere un interprete, un comunicatore e, forse, un simbolo.
La nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia ha scatenato un confronto acceso, in cui il merito artistico è stato presto travolto da logiche di schieramento. Eppure, al di là delle opinioni, resta un dato chiaro: Beatrice Venezi è una musicista solida, con un percorso coerente e un’idea precisa — restituire alla musica classica una vitalità contemporanea, liberandola da certe abitudini che la rendono immobile.
Le sue incisioni (My Journey – Puccini’s Symphonic Works e Heroines, entrambe per Warner Music) mostrano una direzione sobria, più attenta al disegno e al colore che all’effetto, forse non ancora dotata della profondità interpretativa dei grandi maestri, ma già capace di un’idea precisa di suono e struttura.
Il debutto londinese con L’amico Fritz nel 2021 è stato accolto da buona parte della critica britannica come una prova convincente, caratterizzata da equilibrio e senso teatrale.
Non un exploit, ma un passo serio di una carriera in costruzione.
Il nodo, semmai, è altrove: l’Italia fatica a gestire i propri talenti quando non corrispondono agli schemi consueti. Venezi è una figura che si espone, comunica, si lascia leggere. Ciò che per alcuni è leggerezza mediatica, per altri è la capacità — rara — di portare la musica classica nel linguaggio del presente, di renderla meno austera e più permeabile.
Che lo si approvi o meno, è un atto di coraggio: perché nel nostro Paese, dove spesso la cultura preferisce nascondersi dietro l’austerità, chi osa mostrarsi rischia di essere frainteso.
Le tensioni sorte intorno alla sua nomina alla Fenice, con proteste interne e reazioni pubbliche sproporzionate, raccontano una difficoltà più profonda: quella di riconoscere autorevolezza al femminile quando non passa per la discrezione. In questo senso, Beatrice Venezi non è solo una musicista: è anche una cartina di tornasole del nostro modo di intendere il merito, della resistenza a un modello di leadership diverso — meno gerarchico, più dialogico, più aperto alla comunicazione.
La misura del suo lavoro, naturalmente, si vedrà sul podio. Ma sarebbe miope ridurre tutto a una questione di appartenenze o di visibilità. Se riuscirà a consolidare un linguaggio interpretativo personale e a trovare, nel cuore di un’orchestra come quella della Fenice, la fiducia necessaria per costruire qualcosa di duraturo, il tempo — non le polemiche — darà la sua risposta.
In definitiva, Beatrice Venezi non chiede di essere amata o contestata: chiede di essere ascoltata con attenzione, come si ascolta un tema che torna in forma diversa, rivelando una direzione che non avevamo previsto. Forse è questo, oggi, il suo merito più grande: aver riportato la direzione d’orchestra — un gesto antico, quasi rituale — dentro il vivo del discorso culturale contemporaneo.
E se talvolta la polemica si accende, è forse perché in lei la musica non è solo mestiere, ma anche presenza: quella rara, sottile forma di coraggio che consiste nel farsi vedere mentre si prova davvero a cambiare qualcosa.
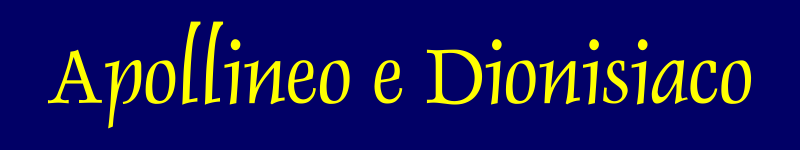
![]()