Matera è una città che non risuona come le altre. La sua voce non nasce dall’alto ma dal profondo: dalle pareti di tufo che assorbono la luce, dal respiro lento dei Sassi che conservano l’eco di chi vi ha abitato. Ogni suono, qui, sembra portare con sé una memoria secolare. Non è un caso che proprio in questo paesaggio, nel febbraio del 1709, vedesse la luce un bambino destinato a cambiare il destino musicale d’Europa: Egidio Romualdo Duni.
Nacque da Francesco, maestro di cappella della Cattedrale, e da Agata Vacca. In quella famiglia il canto non era ornamento, ma mestiere quotidiano, disciplina dell’ascolto e forma di vita. È lecito immaginare che il piccolo Egidio, prima ancora di leggere la musica, imparasse a riconoscere il tono del silenzio, il modo in cui il suono si posa sulle pietre. Forse da qui nasce la sua inclinazione a una musica chiara, essenziale, lucida: una musica che non urla, ma ragiona.
La tradizione lo vuole allievo di Francesco Durante nei conservatori napoletani, e non è improbabile. In quegli anni Napoli era il cuore musicale d’Europa: un laboratorio dove il contrappunto si univa alla teatralità, e il rigore si temperava con l’ironia. Duni assorbì da quella scuola non soltanto la tecnica, ma una concezione etica della composizione: scrivere significava risolvere un problema di equilibrio, non esibire un’emozione. Fu una lezione di disciplina che lo accompagnò per tutta la vita.
La sua carriera italiana cominciò presto e con buon successo: il Nerone (Roma, 1735) gli diede notorietà; seguirono Adriano in Siria e La tirannide debellata, opere che mostrano un talento teatrale istintivo, una scrittura vocale agile e la capacità di coniugare intensità drammatica e chiarezza armonica. Non amava il barocco delle complicazioni: già in queste prime opere si avverte una tendenza al disegno netto, alla simmetria limpida, alla parola comprensibile. In un secolo incline all’enfasi, Duni preferiva la geometria.
Nel 1743 fu nominato maestro di cappella a Bari, poi a Parma, alla corte dei Borbone, dove l’atmosfera cosmopolita lo mise in contatto con musicisti francesi e tedeschi. Parma fu la sua officina segreta. Lì imparò la duttilità di un gusto che non conosce confini: l’arte di tradurre le idee da una lingua all’altra, di fondere la sensibilità italiana con la curiosità illuminista d’oltralpe. Il teatro parigino cominciava a guardare con interesse agli autori italiani, ma la questione era ancora aperta: la lingua francese poteva cantare? Rousseau aveva scritto che no, che il francese era intrinsecamente antimusicale. Duni, da lucano di poche parole e di gesti precisi, rispose senza polemica, con i fatti. Si trasferì a Parigi nel 1757, e pochi anni dopo divenne direttore musicale della Comédie Italienne.
Fu il momento decisivo. In quella città dove tutto tendeva all’intelletto e all’eleganza, Duni portò un senso mediterraneo del ritmo e della frase, la naturalezza del parlato musicale. Inventò — o meglio codificò — la comédie mêlée d’ariettes, la commedia che alternava dialoghi e pezzi cantati, oggi diremmo l’opéra-comique moderna. Ma il suo genio non stava nell’aver creato un genere: stava nell’aver capito che l’opera poteva respirare come la vita, che l’aria non era un’isola ma un ponte, che il canto poteva essere un prolungamento naturale della parola. Duni non teatralizzò la musica, musicalizzò la conversazione.
I francesi lo chiamarono “papa Duni”: un titolo ironico e affettuoso, con cui riconoscevano in lui il maestro di un’arte nuova. Sapevano che era italiano, ma non lo percepivano come straniero. Aveva capito il segreto fonetico del francese — la sua nasalità controllata, la sua prosodia non accentata ma sillabica — e vi aveva costruito sopra una nuova melodia, fondata sulla precisione più che sull’enfasi. Nelle sue ariette non si trova mai la virtuosità vana: tutto serve all’azione, tutto è proporzionato alla parola. Egli seppe dimostrare che la chiarezza non è freddezza, che la grazia è una forma di logica, e che l’ironia può essere un atto morale.
L’opéra-comique di Duni non è un teatro leggero: è un teatro morale sotto forma di sorriso. I suoi personaggi non gridano né declamano; parlano cantando, e il pubblico si riconosce in quella naturalezza. Dietro la commedia si intravede una filosofia: l’uomo come creatura che trova la verità nel quotidiano, non nell’eroismo. Questa è la vera rivoluzione di Duni, infinitamente più profonda di qualunque esperimento formale. In un secolo che inseguiva il sublime, egli restituì dignità all’ordinario.
Non fu un rivoluzionario nel senso moderno del termine: non distrusse, non provocò, non cercò rotture. Fu un riformatore silenzioso, come solo gli spiriti del Sud sanno essere: capaci di cambiare tutto senza che nessuno se ne accorga subito. La sua riforma passò attraverso i dettagli: l’uso dei duetti come motore dell’azione, l’abbreviazione delle arie per evitare la ripetizione, la nuova funzione dell’orchestra come interlocutore e non come sfondo. In ogni battuta si sente il mestiere del compositore che non vuole stupire, ma far funzionare la macchina teatrale. È una lezione di modestia e di intelligenza che ancora oggi suona modernissima.
Con Duni, la musica italiana emigrò in Francia senza smettere d’essere se stessa. Portò con sé l’arte del canto, ma anche la misura morale appresa a Napoli e, più indietro ancora, il senso di compostezza che gli veniva da Matera. Le sue origini lucane non furono un accidente geografico: furono una forma mentale. La Lucania insegna la pazienza, la precisione, l’arte di non sprecare. Duni trasformò queste virtù in estetica: nessuna nota superflua, nessuna teatralità fuori posto.
Il suo destino parigino durò quasi vent’anni. Morì nel 1775, quando Mozart era un ragazzo e Gluck aveva già aperto la via del dramma classico. Eppure, senza di lui, nessuno di quei due mondi sarebbe stato lo stesso. Gluck portò la tragedia al suo compimento, Mozart la sintesi perfetta fra comico e drammatico; ma Duni aveva preparato il terreno, aveva mostrato come la leggerezza potesse contenere profondità, come l’ironia potesse essere una forma di misura.
Da lucano, il suo modo di intendere la “riforma” fu istintivamente concreto: meno proclami, più fatti. Dove Gluck scriveva manifesti, Duni scriveva ariette; dove Rousseau polemizzava, Duni componeva. È la differenza fra chi parla del mondo e chi lo fa funzionare.
Il suo caso è anche un esempio straordinario di come l’Italia meridionale abbia saputo essere europea prima ancora che nazione: Duni a Parigi, Jommelli a Stoccarda, Piccinni a Parigi dopo di lui, Paisiello a Pietroburgo. Tutti partiti da un medesimo orizzonte culturale, quello dei conservatori napoletani, e tutti capaci di farsi ascoltare fuori dai confini senza tradire la loro lingua. Nessuno più di Duni, tuttavia, incarnò questo equilibrio: portò l’Italia in Francia senza smettere di essere lucano.
C’è poi un’altra connessione, quasi simbolica, che lega la sua storia alla mia terra. Pomarico, il paese da cui proviene la mia famiglia materna, è lo stesso luogo in cui nacque il nonno di Antonio Vivaldi. Si potrebbe dire che tra Pomarico e Matera scorre un fiume sotterraneo di musica, una vocazione che ha attraversato i secoli e le frontiere. Vivaldi e Duni: due destini opposti e complementari. Il primo, il fuoco di Venezia, la vertigine del colore, la rapidità del gesto; il secondo, la calma ragione del Sud, la compostezza della forma, il gusto della misura. Due modi di dire la stessa cosa: che la musica non nasce dal caso, ma da un luogo dell’anima.
Oggi, due secoli e mezzo dopo la sua morte, Matera celebra Duni con il Festival che porta il suo nome, giunto alla ventiseiesima edizione. Non è una commemorazione formale, ma un ritorno affettivo. Ogni autunno, tra le chiese rupestri e i palazzi barocchi, risuona quella musica che il tempo aveva lasciato dormire: e sembra che la città intera respiri con lei. Il tema di quest’anno — Patrimoni Sonori — sintetizza perfettamente il senso di questo rito: la consapevolezza che il patrimonio non è un deposito, ma un gesto da ripetere. Portare Duni di nuovo a Matera significa riconsegnargli la patria ideale che non ha mai smesso di appartenergli.
Riascoltare oggi le sue opere — Le peintre amoureux de son modèle, La fée Urgèle, L’école de la jeunesse — è come guardare un disegno architettonico dopo secoli di pittura esuberante: improvvisamente tutto torna leggibile. Nella sua scrittura si respira la sobrietà di un uomo che conosceva il peso del tempo. Le sue melodie non cercano l’effetto, ma la continuità. L’orchestra è tersa, mai ridondante; la voce dialoga, non domina. È una musica che sembra pensata per durare più che per brillare — e infatti dura.
Nell’Italia di oggi, che ha dimenticato troppo spesso i suoi musicisti del Settecento, Duni rappresenta un modello di modernità civile. La sua lezione non riguarda solo la musica, ma il modo di stare al mondo: lavorare con rigore, parlare con misura, unire il sapere artigianale alla curiosità intellettuale. È l’etica del mestiere contro la retorica del genio, la sobrietà contro l’ansia dell’esibizione.
In questo senso, la sua figura parla anche a chi scrive e ascolta oggi, in un tempo di comunicazione frenetica e di memoria corta. Duni ci ricorda che la cultura non nasce dal rumore, ma dal silenzio preparato; che la bellezza non è un’urgenza, ma una costruzione; che la musica, per essere universale, deve prima essere fedele alla propria origine. La sua origine era Matera — e da Matera partì, come tutti quelli che hanno qualcosa da dire, per tornare un giorno da un’altra direzione.
Quando nelle sere d’autunno il Festival Duni accende i suoi concerti e la pietra della città si fa cassa armonica, sembra di sentire non solo le note di un compositore, ma la voce intera di una terra che finalmente si riconosce in chi la rese grande. Forse la vera eredità di Duni non è soltanto la nascita dell’opéra-comique, ma la certezza che anche dalle periferie del mondo può partire una forma di universalità.
E se Matera rappresenta la solidità del tempo, Pomarico ne custodisce la genealogia. Lì nacque il nonno di Vivaldi, e lì si conserva il segreto di un’Italia che ha saputo farsi ascoltare senza clamore. È un triangolo di pietra e suono: Pomarico, Matera, Parigi. Tra queste coordinate si muove la storia di Egidio Romualdo Duni, ma anche una parte di noi, di quella cultura meridiana che unisce la misura alla luce, la logica al sentimento, il rigore alla tenerezza.
Oggi, in un’Europa che sembra aver dimenticato le sue radici mediterranee, ricordare Duni significa ricordare che la vera modernità nasce dalla misura, non dall’eccesso. È il gesto di un uomo che, partendo da una piccola città del Sud, insegnò al mondo come si può essere universali restando fedeli alla propria lingua. In questo senso la sua lezione non è finita: è un invito alla discrezione, all’intelligenza, alla bellezza che non ha bisogno di alzare la voce per farsi sentire.
E così, duecentocinquant’anni dopo, Egidio Romualdo Duni torna a parlare. Non più dai palchi parigini, ma dalle pietre di Matera che gli rispondono come un coro sommesso. La sua musica non è un monumento, ma un respiro: quello di una terra che continua a cantare attraverso chi, come lui, seppe trasformare il silenzio in misura e la misura in libertà.
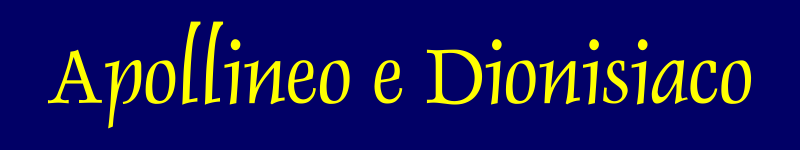
![]()