Non capita spesso di sedersi al Costanzi sapendo di assistere a qualcosa che lì dentro non accadeva da mezzo secolo. La seconda recita di Lohengrin comincia in un clima sorprendentemente quieto: niente atmosfera d’evento costruito, nessuna eccitazione da “prima”, piuttosto la sensazione di rientrare in una stanza che il teatro aveva chiuso troppo a lungo.
Ho scelto di esserci alla seconda, come faccio ogni volta che posso, perché la prima è l’istantanea del debutto e la seconda è il momento in cui lo spettacolo si lascia osservare con più onestà. Quello che ho trovato non è il ritorno trionfale di un titolo assente, ma il movimento paziente di una macchina teatrale che prende sul serio Lohengrin come storia di persone prima che di simboli: una comunità fragile, una donna che vacilla, un uomo che arriva per salvare e finisce per aprire ferite.
L’allestimento sceglie la strada della coerenza interna e di un dialogo stretto fra scena e buca. Sul podio Michele Mariotti, alla sua prima prova wagneriana, costruisce un discorso sonoro di grande chiarezza; in scena Damiano Michieletto, con Mattia Palma alla drammaturgia, Paolo Fantin alle scene, Carla Teti ai costumi e Alessandro Carletti alle luci, disegna una lettura compatta, riconoscibile, che non si lascia sedurre dal folklore cavalleresco e preferisce interrogare ciò che Lohengrin racconta oggi: il bisogno di affidarsi a qualcuno e la paura, quasi immediata, di quel medesimo affidarsi. È una lettura forte, che mette la classicità in un cassetto e, al suo posto, mette davanti agli occhi dello spettatore una serie di domande che fanno trasparire l’inquietudine dei nostri giorni.
Il cuore del lavoro di Michieletto è lo sguardo sulla comunità. Il popolo di Brabante diventa un’assemblea compatta, quasi un coro greco di provincia: guarda, giudica, stringe i personaggi in un cerchio che si allarga e si restringe, li mette letteralmente al centro. La vicenda sembra un processo che non finisce mai: più che la redenzione, a dominare è la miscela di colpa, sospetto e bisogno di credere. Il mistero dell’identità di Lohengrin è solo uno dei nodi di un conflitto più ampio fra desiderio di fede e paura dell’ignoto.
Fantin traduce tutto questo in un unico grande spazio curvo, non inquietante ma addirittura luminoso: una struttura lignea che richiama insieme tribunale, recinto, ventre. Nel primo atto il legno giallastro è un guscio chiuso, caldo e oppressivo: incornicia i gruppi, delimita i percorsi, crea naturalmente luoghi di isolamento e di assedio. Nel secondo atto la scena si concentra attorno a un grande uovo scuro, segno d’origine e di ambivalenza: è culla e minaccia, promessa e pericolo. Nel terzo atto, quando la domanda proibita viene finalmente pronunciata, la materia si trasforma: l’argento invade lo spazio, l’uovo si apre, le superfici diventano riflettenti, scivolose, quasi inafferrabili. Il gioco fra legno e metallo non è un semplice effetto estetico: il legno appartiene alla dimensione umana, porosa, finita; le superfici argentate, fredde e fluide, alludono a una regione altra, affine al mondo di Lohengrin, che attrae e insieme respinge.
L’elemento dell’uovo entra come segno forte, ma non come allegoria martellante: è un oggetto che abita la scena e concentra gli sguardi, più che una chiave interpretativa imposta. Molto più determinante, alla prova dei fatti, è il modo in cui questo spazio costringe i corpi: basta guardare Elsa quando la comunità le si chiude intorno, o Telramund che scivola ai margini di questo guscio per capire dove la regia vuole portare lo sguardo.
Il celebre motivo del cigno è volutamente depotenziato sul piano illustrativo. Non c’è nessun grande animale scenico a rubare lo sguardo: l’immagine sopravvive come traccia, come dettaglio, come segno da decifrare, mentre la regia insiste sulle conseguenze concrete del suo apparire e del suo svanire nei corpi dei personaggi e nei loro rapporti di forza. La direzione attoriale degli interpreti è curata con precisione: Elsa è costantemente collocata al centro di un sistema di vettori opposti – desiderio di abbandonarsi a una promessa di salvezza, esigenza di comprendere e nominare ciò che le accade; Lohengrin non è l’eroe monolitico, ma un uomo che porta addosso il peso del proprio status; Ortrud agisce come una stratega del dubbio, lucida e insinuante; Telramund è figura segnata, più spinta da risentimenti e frustrazioni che da un semplice istinto di sopraffazione.
I costumi di Carla Teti sigillano questa sospensione temporale: non siamo né in un Medioevo da libro illustrato né in un contemporaneo strettamente naturalistico. Le linee sono essenziali, con accenti che suggeriscono memorie novecentesche e allusioni politiche senza trasformarsi in didascalia. Le luci di Alessandro Carletti lavorano sull’alternanza di tagli netti e zone d’ombra, abbacinamenti improvvisi e penombre da camera interiore: illuminano e cancellano, rivelano e feriscono, contribuendo in modo determinante alla percezione di un mondo che, via via, si fa sempre meno stabile.
Sul versante musicale, Mariotti propone un Lohengrin di grande trasparenza. La lettura evita qualunque tentazione monumentale e costruisce un Wagner terso, teso, scolpito con cura nei rapporti interni. La concertazione non si concede mai agli eccessi del volume, preferisce il dettaglio alla massa e la linea all’impatto. L’orchestra risponde con precisione, con un gioco di piani sonori netto e un equilibrio costante fra archi e fiati. Sorprende la naturalezza con cui Mariotti affronta un titolo che richiede un senso del respiro drammatico tutt’altro che scontato: la sua interpretazione mantiene una limpidezza orchestrale quasi cristallina nei punti chiave, con una rarefazione dei piani sonori che permette alla struttura wagneriana di emergere con una chiarezza rara.
Non è una trasparenza debole né un alleggerimento estetico: è un lavoro di cesello, di lucidità costante, che restituisce alla partitura un equilibrio interno spesso sacrificato altrove. In più di un momento questa chiarezza risulta più convincente di prove recenti ascoltate in teatri ben più legati per tradizione al repertorio wagneriano. C’è una maturità non ostentata, una sicurezza priva di compiacimento, che colloca questa lettura su un livello alto, davvero alto. Mariotti ha lavorato sulla chiarezza narrativa senza perdere la tensione interna della partitura, e accompagna le voci senza coprirle né lasciarle scoperte.
L’orchestra del Teatro dell’Opera, dicevamo, risponde con una compattezza non appesantita: gli archi mantengono un profilo morbido ma non sfocato, i legni emergono in tutta la loro funzione narrante, gli ottoni sono presenti e controllati, senza derive roboanti. L’attenzione al respiro teatrale è costante: i tempi hanno una tensione di base che evita la staticità, ma restano elasticamente ancorati alle esigenze della parola cantata e ai tempi scenici. Il disegno complessivo risulta infine luminoso, stratificato senza essere opaco: un Wagner in cui l’intreccio delle voci interne è percepibile, in cui i leitmotiv emergono come linee di forza naturali e non come segni sovrapposti.
Il Coro del Teatro dell’Opera, preparato da Ciro Visco, è uno degli strumenti principali di questo spettacolo. Gestito con flessibilità dinamica, passa da masse compatte di suono a filigrane più tenui senza perdere precisione d’intonazione o compattezza di attacco. In un allestimento che fa della comunità un personaggio decisivo, questa risposta di livello diventa fondamentale: sia nei grandi blocchi cerimoniali sia nei momenti in cui la folla si fa quasi sussurro, il coro sostiene e amplifica le scelte registiche.
Nel ruolo del titolo, Dmitry Korchak disegna un Lohengrin lirico e concentrato, lontano dal modello esclusivamente “eroico”. La linea trae vantaggio dalla sua esperienza belcantistica: attenzione continua all’arco della frase, cura della dinamica, intelligenza nel rapporto con l’orchestra. La figura che ne risulta è quella di un cavaliere meno granitico, più inclinato alla fragilità, coerente con un’idea di personaggio che non domina semplicemente gli eventi, ma ne è a tratti travolto.
Jennifer Holloway offre un’Elsa di grande coerenza interna. Il timbro chiaro, la tenuta del legato e il controllo delle mezzevoci le permettono di attraversare il percorso del personaggio senza cedimenti stilistici: dal racconto del sogno iniziale fino al duetto del terzo atto, si avverte un disegno consapevole, in cui il progressivo incrinarsi della fiducia si riflette nel colore e nell’accento, non solo nei gesti. L’integrazione con la regia – soprattutto nei lunghi momenti in cui Elsa è letteralmente circondata e osservata dalla comunità – è uno dei punti di forza dello spettacolo.
Ekaterina Gubanova è un’Ortrud di grande impatto. L’ampiezza del registro centrale, la proiezione sicura, la padronanza dei piani dinamici le consentono di modellare la parte con libertà, senza mai perdere definizione. Le invocazioni pagane hanno una forza quasi rituale, ma sempre controllata; i dialoghi con Telramund sono scolpiti con una precisione che rende percepibile la natura manipolatoria del personaggio. Nel secondo atto, la sua presenza incide sulla percezione generale della scena: ogni gesto e ogni sguardo contribuiscono a far salire il livello di tensione.
Tómas Tómasson, come Telramund, unisce alla solidità vocale una forte presenza scenica. Il personaggio acquista una dimensione quasi tragica: non semplice antagonista di servizio, ma uomo segnato che viene risucchiato, insieme a Ortrud, in una spirale di rancore e sconfitta. La capacità di modellare la parola, di far emergere le diverse sfumature del testo, rende credibile questo percorso.
Clive Bayley presta a re Enrico un’autorevolezza naturale, fatta di misura e di controllo più che di enfasi. La voce conserva un nucleo di nobiltà timbrica che si sposa bene con il tratteggio registico: sovrano che entra ed esce da un mondo che non riesce a ricomporre del tutto, garante di un ordine più evocato che realmente praticabile.
Andrei Bondarenko, come Araldo, firma un intervento esemplare per chiarezza e musicalità: ogni apparizione è nitida, ben appoggiata sul respiro, con una dizione che rende immediatamente comprensibile il ruolo di voce del potere che gli affida la partitura. Ne risulta una figura minore solo sulla carta, ma decisiva nell’equilibrio dei pesi teatrali.
I giovani della “Fabbrica” – Alejo Álvarez Castillo, Dayu Xu, Guangwei Yao, Jiacheng Fan nei ruoli dei nobili, e Mariko Iizuka, Cristina Tarantino, Silvia Pasini, Caterina D’Angelo come paggi – si inseriscono con grande naturalezza nel tessuto della serata. Le voci sono omogenee, musicali, già ben orientate stilisticamente; la regia li utilizza con intelligenza, valorizzandone la freschezza scenica.
La risposta della sala è calorosa e protratta: gli applausi insistono su orchestra, coro e protagonisti, ma coinvolgono l’intera squadra creativa. Più che l’effetto di uno spettacolo a tesi, resta la sensazione di un lavoro d’insieme solido, in cui ogni comparto è chiamato a sostenere un’idea chiara: mettere al centro non l’icona del cavaliere miracoloso, ma la comunità che oscilla fra bisogno di affidarsi e furia di inquisire. In questo senso, il Lohengrin romano segna una tappa importante nel rapporto del Costanzi con Wagner e consegna al teatro una produzione pensata, riconoscibile e perfettamente in grado di reggere il palcoscenico anche per stagioni future. Perché Lohengrin non può restare in silenzio per altri cinquant’anni: deve ritornare più spesso al Costanzi, con la qualità che abbiamo ascoltato questa volta.
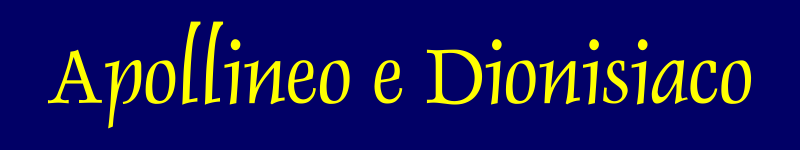
![]()